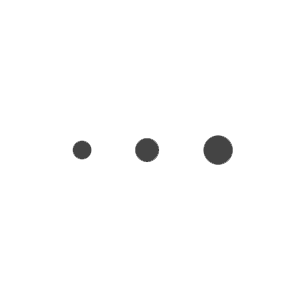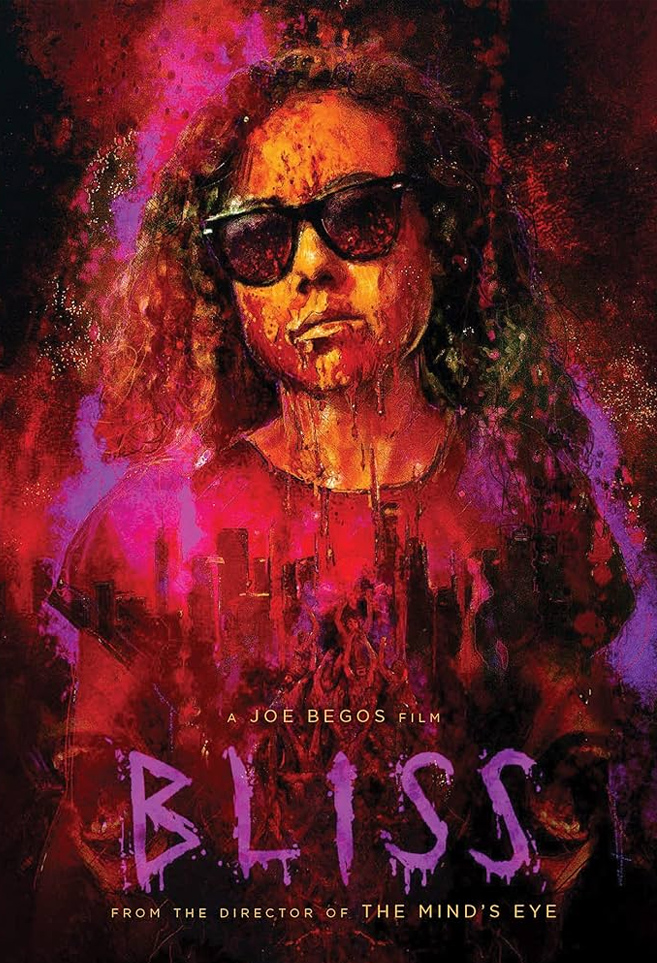
Bliss
di Joe Begos
Joe Begos è un giovane regista e sceneggiatore americano con all’attivo diversi film horror, non tutti memorabili, va detto. Si è però imposto per uno stile viscerale e diretto, un’anima profondamente splatter e una narrazione estrema che gli hanno garantito una certa visibilità nel panorama horror indipendente. Nel 2019 scrive, dirige e produce Bliss, il film che segna la sua maturità artistica.
Fin dai titoli di testa, dai colori sgargianti e aggressivi, il film sconsiglia caldamente la visione a chi soffre di epilessia. Un avviso da prendere sul serio, dal momento che la pellicola è un susseguirsi di luci stroboscopiche e immagini montate a ritmo serrato, un bombardamento sensoriale capace di farti girare la testa.
Dezzy (Dora Madison) è una giovane pittrice che vive a Los Angeles intrappolata in una profonda crisi creativa. Le scadenze incombono, il suo agente l’ha mollata e l’ispirazione sembra definitivamente scomparsa. Nel tentativo di sbloccarsi decide di affidarsi al suo spacciatore di fiducia, provare una nuova droga chiamata Bliss e lasciarsi risucchiare dalla vita notturna della città, tra alcol, sesso occasionale e droghe di ogni tipo.
La sostanza sembra promettere un’esplosione di creatività, ma dopo un threesome particolarmente cruento con una coppia misteriosa, Dezzy sprofonda in un delirio allucinogeno e inizia a sviluppare una fame insaziabile di sangue.
Bliss è un film sfacciatamente derivativo, un frullato di citazioni che Begos non prova nemmeno a nascondere. C’è l’ossessione vampiresca e urbana di The Addiction di Abel Ferrara, c’è un montaggio frenetico e ansiogeno che richiama i momenti più allucinati di Requiem for a Dream di Aronofsky, e poi ci sono quei colori fluo, accesi e quasi violenti, che sembrano urlare Nicolas Winding Refn da ogni fotogramma.
Eppure, nonostante questa evidente mancanza di originalità strutturale, Bliss riesce comunque a intrattenere e a lasciare il segno. La vera forza del film non sta tanto in quello che racconta, Begos non sembra davvero interessato a costruire una metafora complessa sulla creatività o sull’artista contemporaneo, quanto nel modo in cui lo fa. È un trip allucinogeno girato in 16mm, sporco e sgranato, che punta dritto allo stomaco e ai sensi dello spettatore senza chiedere scusa.
La Los Angeles messa in scena da Begos è decadente e sudicia, accompagnata da una colonna sonora che spazia dal doom metal al punk, dal noise all’industrial e all’hard rock, e che martella senza tregua dall’inizio alla fine. Più che un film, Bliss sembra un videoclip cruento ed eccessivo lungo ottanta minuti. Ettolitri di sangue scorrono con un gusto estetico quasi psichedelico, in un delirio visivo che non concede respiro.
È puro intrattenimento per chi ha voglia di salire sulle montagne russe e godersi lo schianto finale con il sorriso sulle labbra. Se invece siete in cerca di profondità, di una sceneggiatura articolata o di dialoghi elaborati, un consiglio da amico, girate al largo. Qui non c’è spazio per la riflessione, c’è solo il rumore, il colore e un fottuto, meraviglioso caos.

Storia di un matrimonio
di Noah Baumbach
In un impeto di autolesionismo o forse soltanto in cerca di qualcosa di diverso dai miei soliti horror ho deciso di vedermi Storia di un matrimonio (Marriage Story, 2019) di Noah Baumbach. Risultato? Una mazzata. Sarà che quell’inferno l’ho vissuto sulla mia pelle in tempi recenti, ma questo film mi ha fatto rimpiangere i miei amati mostri. Loro, almeno, se vogliono mangiarti il cuore non ti mandano prima una lettera dell’avvocato.
Charlie (Adam Driver) è un regista teatrale newyorkese di discreto successo. Nicole (Scarlett Johansson), sua moglie, è un’attrice californiana che per anni è stata il volto principale della compagnia da lui diretta. I due hanno un bambino di otto anni, Henry. Mentre Charlie prepara il suo debutto a Broadway, Nicole - che ha messo spesso in pausa la sua carriera per seguirlo - accetta di interpretare il pilot di una serie tv e decide di tornare a Los Angeles portando con sé il figlio. È l’inizio della loro separazione. Quello che nasce come un tentativo di lasciarsi in modo amichevole, civile, "senza avvocati", deraglia rovinosamente quando Nicole, spinta da un nuovo senso di indipendenza, si affida a una legale. Da quel momento la vita privata di due persone che si sono amate diventa un fascicolo, una strategia, una guerra di logoramento emotiva e straziante.
La grandezza di Baumbach sta nel rifiutare la facile retorica del colpevole. La sceneggiatura mantiene un equilibrio miracoloso tra i due punti di vista senza mai cadere nel giudizio. Non ci sono mostri né santi, solo due persone che a un certo punto non riescono più a comunicare. La frattura non nasce da un tradimento o da un gesto plateale, ma da un’usura lenta e quasi invisibile. È quel disamore silenzioso fatto di piccole rinunce che sembrano nulla finché un giorno non pesano come macigni.
Adam Driver e Scarlett Johansson sono semplicemente monumentali. Così credibili, così dolorosamente vulnerabili, che per ampi tratti sembra di osservare due esseri umani reali che si spezzano lentamente, pezzo dopo pezzo, davanti ai tuoi occhi. Charlie è egoista e controllante, ma sinceramente convinto di amare la sua famiglia. Nicole ha motivazioni legittime per andarsene, ma anche lei non esita a usare armi sleali quando serve. Sono terribilmente umani, con tutte le contraddizioni che questo comporta.
Il vero "orrore" arriva con l'entrata in scena degli avvocati. È qui che Storia di un matrimonio colpisce duro e dove ho sentito il colpo più forte, rivivendo dinamiche che conosco purtroppo molto bene. Il film mostra la cinica brutalità di un sistema legale che si nutre delle debolezze umane. Laura Dern (nei panni della spietata avvocata di lei) e Ray Liotta (lo squalo che difende lui) sono magnifici nel rappresentare il male necessario. Sono professionisti che fanno il loro lavoro. Ed è proprio questo che li rende terrificanti. Sono figure che riescono a manipolare la fragilità di due persone disperate. Arrivano quando sei vulnerabile, quando vorresti solo che tutto finisse in fretta, e ti parlano con una dolcezza materna o paterna che ti disarma. Ti dicono che "capisci la tua situazione", che "meriti giustizia", che "è ora di pensare a te stesso". E prima che tu te ne accorga, stai firmando per strategie aggressive che mai avresti immaginato di approvare. Ti convincono che l'altro è il nemico, che ogni gesto passato era un calcolo, costringendoti a difenderti con le stesse armi sporche. Ti ritrovi, come Charlie, debole e con le spalle al muro, spinto a compiere scelte scellerate non perché lo vuoi, ma perché un avvocato ti dice che è l'unico modo per non soccombere. È una catena di errori guidata da parcelle salate, dove l'umanità viene tritata in nome della "migliore strategia processuale".
Vedere Storia di un matrimonio è stato un pugno nello stomaco e non mi nascondo ad ammettere che nel finale ho versato qualche lacrima insieme ai due protagonisti.
Alla fine è un film sulla perdita di un’idea di futuro di coppia, della certezza, del “noi”, di un progetto condiviso. Ma nel vedere nel finale Nicole allacciare le scarpe di Charlie mi ha fatto pensare che la separazione non azzera ciò che è stato, non cancella il passato. Semplicemente lo riformula. In una nuova quotidianità. Con ferite che possono restare aperte per sempre.
Ora però torno volentieri ai miei horror.
Film
Il signor Diavolo
di Pupi Avati
Nel 2019, Pupi Avati – maestro del cinema italiano da sempre attratto dai territori ambigui dell’occulto e della memoria, come dimostrano La casa dalle finestre che ridono e L’arcano incantatore – torna al genere che meglio gli appartiene con Il signor Diavolo, un horror rurale che affonda le radici nella tradizione del gotico padano. Con la sua consueta sensibilità per l’inquietudine quotidiana, Avati ci porta in una provincia veneta cattolicissima, sospesa tra fede cieca e superstizione popolare.
La storia è ambientata nell’autunno del 1952, in una frazione lagunare del Veneto. Un giovane funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia (Gabriele Lo Giudice) viene inviato da Roma per indagare su un caso delicatissimo: un ragazzo di quattordici anni, Carlo Mongiorgi, ha ucciso un coetaneo, Emilio Vestri Musy, sostenendo che fosse “il Diavolo in persona”. Il caso rischia di mettere in imbarazzo la Democrazia Cristiana, il partito politico che all’epoca era alla guida del paese e molto legato alla chiesa cattolica. Attraverso una serie di flashback e testimonianze, si ricostruisce un mondo dominato da fanatismo, pregiudizio e paure ataviche. Emilio, figlio di una famiglia influente, viene descritto come una creatura disturbante, con denti animaleschi e un comportamento inquietante, al punto da essere temuto dai suoi stessi compagni di catechismo. La figura del “bambino-demonio” nasce dall’immaginario collettivo, alimentata da una religiosità più vicina al terrore che alla speranza. L’indagine, presto, si trasforma in un viaggio sempre più incerto, in cui razionalità e superstizione si confondono, e il male sembra potersi manifestare in forme del tutto ordinarie.
Il signor Diavolo è un film che lascia sensazioni ambivalenti. Girato con mezzi limitati, presenta una fotografia desaturata, dominata da toni marroni, che restituisce un certo sapore d’epoca ma finisce per appiattire l’immagine. Il sonoro è debole, con dialoghi spesso sussurrati e difficili da seguire, mentre la messa in scena richiama per ritmo e impostazione quella degli sceneggiati della RAI. A questo si aggiungono un protagonista poco carismatico, una sceneggiatura discontinua e un finale un pò troppo sbrigativo.
Eppure, nonostante i limiti, il film ha quel sapore nostalgico apprezzato dagli amanti del cinema del passato. I riferimenti storici sono ben calibrati e restituiscono un’Italia del dopoguerra ancora profondamente immersa nella religione, dove politica e fede si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Le location agresti – campi brulli, chiese isolate, canoniche polverose – sono perfettamente in linea con l’estetica avatiana e contribuiscono a creare un’atmosfera autentica, carica di inquietudine.
Il cast, almeno quello composto da volti noti del cinema di Avati come Gianni Cavina, Lino Capolicchio e Alessandro Haber, offre interpretazioni capaci di compensare le prove anonime e fastidiosamente sussurrate dei giovani attori. Da segnalare anche la buona prova di Chiara Caselli nel ruolo della madre di Emilio, figura ambigua e carica di tensione.
Più che spaventare, Il signor Diavolo lavora sulla suggestione, sul non detto, sull’idea che il male possa annidarsi nelle pieghe più banali della realtà. È un film nostalgico, forse anche un po’ autocelebrativo, ma elegante e coerente con il percorso autoriale di Avati. Un'opera che guarda a un’Italia scomparsa, ma ancora capace di farci tremare, se solo sappiamo ascoltarne i fantasmi.
Film
Il colore venuto dallo spazio
di Richard Stanley
Recentemente mi è capitato di leggere una lista degli horror preferiti da Trent Reznor – la mente dietro i Nine Inch Nails – e tra i titoli spiccava Il colore venuto dallo spazio. Strano a dirsi, ma era uno dei pochi della lista che non avevo ancora visto. Incuriosito, me lo sono subito recuperato.
Il film è diretto da Richard Stanley, nome che forse ai più suonerà vago, ma che nei primi anni novanta ha firmato due chicche di fantascienza a basso budget considerate dei cult dagli amanti del genere: Hardware, un cyberpunk post-apocalittico alquanto sperimentale, e Demoniaca, un road movie horror ambientato in Sudafrica. Dopo un lungo esilio dai set (complice il disastro produttivo de L'isola del dottor Moreau), Stanley torna dietro la macchina da presa nel 2019 adattando per il cinema l’omonimo racconto di H.P. Lovecraft, uno dei più evocativi e indecifrabili della sua intera produzione.
Nathan Gardner (Nicolas Cage) si è trasferito con la famiglia nella campagna del New England per iniziare una nuova vita, lontano dal caos urbano. La loro tranquillità viene però spezzata dall’impatto di un misterioso meteorite nel terreno vicino casa. Da quel momento, le piante assumono colori innaturali, gli animali mutano e le persone iniziano a comportarsi in modo sempre più strano. Una forza aliena, imperscrutabile e invisibile, sembra insinuarsi lentamente nella materia stessa delle cose. Un colore che non dovrebbe esistere sta trasformando la realtà.
Trasporre Lovecraft al cinema è da sempre un’impresa disperata. Il suo orrore è cosmico, sfuggente, basato sull’indecifrabile. Eppure, Il colore venuto dallo spazio riesce – pur con qualche inciampo – a catturare un senso di smarrimento e contaminazione che su schermo funziona sorprendentemente bene. Stanley imbastisce un’ambientazione familiare in una casa isolata nel bosco, dove tutto viene lentamente corrotto da un elemento che non si riesce a nominare, né a comprendere. La scelta di usare un’esplosione cromatica digitale per rappresentare l’entità aliena è audace e forse non sempre elegante, ma rende bene l’idea di una presenza che non appartiene al nostro spettro percettivo.
Nicolas Cage, va detto, non è mai stato tra i miei attori preferiti. Qui però trova terreno fertile per la sua ormai tipica recitazione sopra le righe, che si sposa bene con l’andamento delirante della storia. La sua discesa nella follia – tra urla, occhi spiritati e crisi isteriche – diventa paradossalmente uno degli elementi più coerenti del film.
Non credo di essere il solo ad aver trovato un forte parallelismo con Annihilation di Alex Garland. Anche lì c’è una forza aliena che altera la genetica, lo spazio e la percezione, trasformando il paesaggio in qualcosa di bellissimo e mostruoso. Ma dove Garland resta più cerebrale, Stanley affonda nel viscerale, prendendo una deriva body horror, soprattutto nella seconda parte, parecchio più esplicita e delirante.
Ci sono momenti in cui il film sembra perdersi nel proprio trip psichedelico, e non tutto funziona (sia nella trama che negli effetti speciali, un po’ grezzi), ma la sensazione di spaesamento, l’atmosfera di minaccia invisibile e quel finale opprimente e straniante – che ritrae la lenta dissoluzione dei protagonisti – lo rendono, alla fine, abbastanza convincente.
Non un film perfetto, nulla di memorabile, ma rimane una delle trasposizioni lovecraftiane più interessanti.
Film
Vivarium
di Lorcan Finnegan
Quando ho letto la trama di questo film, mi sono detto ecco un altra storia in cui i protagonisti finiscono in una cittadina, in questo caso un quartiere di periferia, da cui non riescono a uscire perchè ogni strada li riporta al punto di partenza. Da Wayward Pines a From, da Dark City a The Truman Show, il tema della "città-trappola" è stato esplorato numerose volte e in molteplici varianti.
Vivarium, però, non è solo un film di fantascienza claustrofobico, ma una metafora feroce sulla routine, la famiglia e l’incubo del conformismo. Diretto dall’irlandese Lorcan Finnegan, questo thriller esistenziale e surreale prende il concetto della casa perfetta e lo trasforma in un incubo senza uscita. Un'opera che sembra rubata a una puntata de I confini della realtà, – episodio 30 della quinta stagione – ma che scava più a fondo, affontando temi come la disumanizzazione della quotidianità, il peso delle aspettative sociali e la famiglia come trappola evolutiva.
Gemma (Imogen Poots) e Tom (Jesse Eisenberg), una giovane coppia alla ricerca di una casa in cui andare a vivere, si rivolgono a uno strambo e inquietante agente immobiliare (Jonathan Aris) che li conduce nel quartiere residenziale di Yonder, un complesso di recente costruzione, ancora disabitato, composto da una schiera di villette tutte uguali. Il quartiere è avvolto da un silenzio innaturale, il cielo è irreale, e tutto sembra artificioso. Accompagnati dall'agente immobiliare, la coppia entra nella villetta numero nove ma appena visitano il giardino sul retro, l'uomo inspiegabilmente sparisce. I due ragazzi risalgono in macchina per andare via, ma per quanto girino e rigirino, tutte le strade finiscono sempre per ricondurli allo stesso punto, davanti alla villetta numero 9. Trascorrono i giorni e i tentativi disperati di lasciare il posto si trasformano presto in rassegnazione, finché una mattina trovano davanti alla porta una scatola con dentro un neonato e un messaggio che invita i due poveri ragazzi ad accudire il bambino se vogliono riconquistare la libertà.
Vivarium è un film che si presta a una duplice lettura.
Da una parte abbiamo quella prettamente fantascientifica che ci fa intendere [spoiler on] che i due protagonisti siano stati rapiti da una civiltà aliena, o comunque da delle creature parassitarie, che li tengono in un vivarium - termine usato dagli antichi romani per indicare un allevamento - affinchè possano crescere la propria progenie, destinata a rimpiazzare gli esseri umani [spoiler off]. Naturalmente, è solo una mia interpretazione, perché il film non da molte spiegazioni e risposte chiare.
Dall'altra, il film ha un significato allegorico, Il quartiere-labirinto diventa il simbolo della vita moderna, del sogno borghese preconfezionato che si trasforma in una prigione. La coppia di protagonisti è vittima di un sistema che li ha incasellati nel ruolo di genitori senza via di fuga. Il bambino non è solo un figlio indesiderato, ma l’incarnazione della pressione sociale: crescere una creatura che non si comprende, che non restituisce amore, che si nutre della tua energia e che ti scarica, gettandoti in una fossa, quando non sei più necessario.
A livello estetico, il film è un gioiello. Le scenografie riportano ai quadri di Magritte e Hopper, mentre la fotografia dai colori pastello trasforma la perfezione di Yonder in un inferno sterile. Vivarium è un horror esistenziale che parla di routine, di alienazione, dell’orrore della prevedibilità. Ed è proprio questa assenza di una via d’uscita a renderlo così disturbante.
Certo, il film non è perfetto. Nella seconda metà la ripetitività rischia di smorzare l’impatto, e chi cerca una narrazione più dinamica potrebbe trovarlo frustrante. Tuttavia è un film che non si dimentica, che scava dentro di noi, come Tom con la sua buca infinita. E, una volta finito, lascia solo una certezza che non c’è via di fuga dal sistema.
Disturbante, claustrofobico, essenziale. Un Black Mirror ancora più crudele.

The Nest (Il nido)
di Roberto De Feo
A Classic Horror Story, il film diretto da De Feo insieme a Strippoli che ho visto di recente, non mi era dispiaciuto quindi ho recuperato il primo film di De Feo con la speranza di vedere qualcosa di interessante.
In una imponente tenuta di campagna, Elena (Francesca Cavallin), una donna severa e glaciale, cresce il figlio paraplegico Samuel (Justin Korovkin) nel più totale isolamento. Al giovane, poco più che adolescente, viene impedito di uscire all'esterno delle mure di cinta ed è costretto dalla asfissiante madre a seguire delle rigide regole e suonare Bach al pianoforte. Insieme a loro, troviamo la servitù, lo zio del ragazzino e un inquietante medico (Maurizio Lombardi) ai quali è imposto di non parlare del mondo al di fuori della villa e del loro passato. Quando Samuel inizia a sentirsi prigioniero in una gabbia dorata, l'arrivo di Denise (Ginevra Francesconi), una ragazzina poco più grande di lui figlia di un amico di famiglia, scatena in lui l'impellente desiderio di fuggire e scoprire il mondo esterno.
Il film di De Feo è un thriller psicologico, cupo e claustrofobico. La fotografia ha dei toni freddi ed è virata prevelantemente in verde contribuendo a rendere l'atmosfera del film opprimente e malsana. I riferimenti a The Others di Amenabare e The Village di Shyamalan sono evidenti così come l'omaggio a un certo genere di horror gotico e misterioso della letteratura dei primi del novecento. La regia tende a valorizzare le ricche scenografie della villa con lunghi piani sequenza ma il ritmo lento e compassato, degli scricchiolii nella trama, e l'interpretazione degli attori (si salva solo l'algida Cavallin) dilata la tensione fino a un finale abbastanza prevedibile.
Apprezzo sinceramente l'impegno di alcuni giovani registi emergenti nel riportare in Italia film di un genere di cui eravamo maestri indiscussi in passato. Tuttavia, accontanando l'elogio nel fare pellicole diverse dai soliti schemi, se questo film fosse stato prodotto all'estero avrei avuto serie difficoltà a dargli una sufficienza.
Nonostante la sceneggiatura a tratti lacunosa il film sembra aver riscosso un buon successo di pubblico e critica, tanto che si prospetta anche un remake in lingua inglese.
Film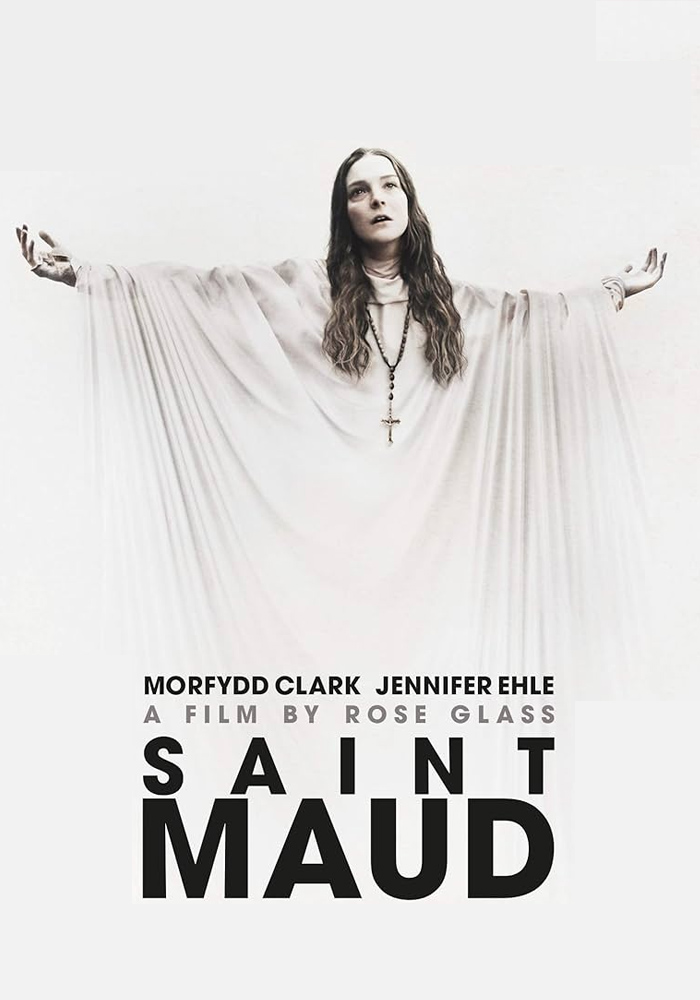
Saint Maud
di Rose Glass
Saint Maud è un film inglese del 2019 di genere dramma horror-psicologico, diretto da Rose Glass al suo debutto alla regia.
La protagonista del film è una giovane infermiera di nome Maud (Morfydd Clark) che dopo essere stata licenziata dall'ospedale in cui lavorava assiste le persone gravemente malate nelle loro case. Maud ha una forte e ossessiva fede cattolica ed è convita che Dio le parli indicandogli la strada per la redenzione. Quando incontra Amanda (Jennifer Ehle), una ex ballerina dal carattere forte e disinibito ora malata terminale di cancro, Maud sviluppa una vera e propria ossessione per lei, convincendosi di potergli salvare l'anima. Inizialmente Amanda accoglie con curiosita e simpatia la fervida badante ma quando Maud cerca di nascosto di allontanare Carol, una ragazza con cui l'ex ballerina era solita avere rapporti sessuali, la donna organizza una festa di compleanno durante la quale schernisce Maud di fronte a tutti per poi licenziarla.
Senza amici, sola e depressa, Maud si rifugia in una malsana e deviata fede religiosa sottoponendosi a torture fisiche per espiare i propri peccati. L'instabilità mentale già molto precaria sfocia in follia e Maud, sempre ossessionata da Amanda, si convince di essere un angelo compiendo l'atto finale dalla sua triste esistenza.
Ottimo esordio per la regista inglese che realizza un film molto particolare con un montaggio e una fotografia sublime. Originale l'idea che il tema della possessione sia invertita, ovvero che sia lo Spirito Santo e non il demonio a condurre alla follia la protagonista. Un delirio in cui il soprannaturale si confonde con la realtà espressa in tutta la sua crudezza nella drammatica scena finale (in particolare nell'ultimo frame).
Film
Midsommar
di Ari Aster
Midsommar è il secondo film scritto e diretto da Ari Aster dopo l'ottimo Hereditary. Uscito nei cinema nel 2019, Midsommar - Il villaggio dei dannati (altro sottotitolo italiano che poteva essere evitato) è un folk horror atipico, per certi versi quasi grottesco, dalle diverse chiave di lettura (tossicità del rapporto di coppia, emancipazione femminile, misoginia).
Dani (una bravissima Florence Pugh) è una giovane ragazza americana che ha una relazione di forte dipendenza con Christian (Jack Reynor), un ragazzo che ha molti dubbi sul loro rapporto ma non ha il coraggio di lasciarla. Quando la sorella bipolare di Dani si uccide, uccidendo anche i loro genitori, Christian si sente quasi obbligato a portare Dani con sè in Svezia, in un viaggio che avevo organizzato con i suoi amici in estate per visitare un villaggio tradizionale dove si celebra il solstizio d'estate, una speciale ricorrenza che si svolge ogni novanta anni per la durata di nove giorni. Raggiunto Hårga, nella provincia di Hälsingland, i ragazzi vengono accolti con gioia, sorrisi e funghi allucinogeni dalla gente della comunità. Inizialmente tutto sembra nuovo e stimolante ma pian piano emerge la vera essenza di queste persone, seguaci di un culto neopagano rivolto al femminile.
Midsommar è un horror molto particolare, innanzitutto, fatta eccezione per la prima parte, è un horror che non solo rinuncia al buio ma è quasi accecante nella sua luminosità. Più che sulla paura, il film fa leva sulla tensione, l'ansia e l'angoscia. L'ambientazione bucolica mi ha ricordato il The Village di Shyamalan mentre da più parti leggo che il film di Aster deve molto a The Wicker Man, un film inglese del 1973 che personalmente non conosco. In tutti i modi Midsommar è un film girato benissimo, con una fotografia spettacolare e delle brillanti trovate registiche (tra queste la sequenza in cui i ragazzi in macchina giungono ad Hårga con la strada che si capovolge come a evidenziare di aver varcato un altra dimensione dove le regole sono diverse da quelle che conosciamo).
Interessante i disegni rivelatori e i tanti particolari disseminati nel film (vedere il quadro con l'orso nella stanza di Dani all'inizio del film).
Nonostante sia un film emotivamente pesante e superi le due ore Midsommar è capace di lasciarti inchiodato allo schermo.
Film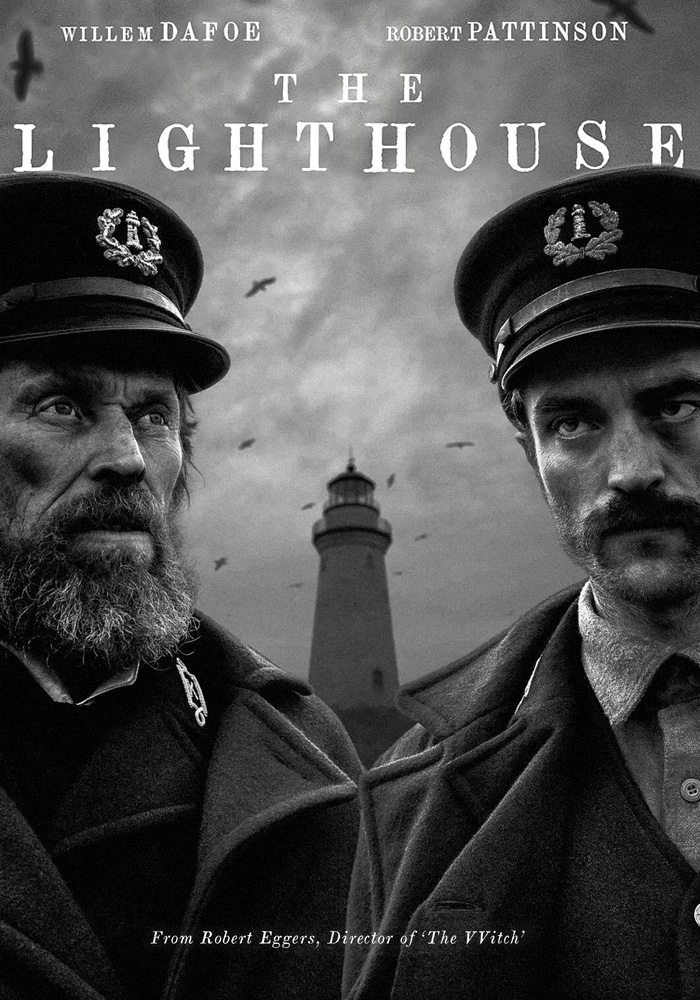
The Lighthouse
di Robert Eggers
The Lighthouse del 2019 è il secondo film di Robert Eggers dopo The Witch (che non ho visto e che intendo recuperare quanto prima).
Un horror, un thriller, un dramma sulla follia? È difficile trovargli una collocazione. Quel che è certo, almeno per quanto mi riguarda, è che siamo di fronte a un capolavoro.
Fine dell’ottocento. Thomas Wake (un grande Willem Dafoe) e il nuovo assistente, Ephraim Winslow (un altrettanto bravo Robert Pattinson) giungono in un remoto isolotto del New England per occuparsi della manutenzione di un faro. I due dovranno rimanere isolati per quattro settimane in attesa del traghetto che li riporterà a casa. Ephraim si ritrova a sottostare agli ordini del vecchio e irascibile Thomas che lo costringe alla maggior parte dei lavori manuali, mentre Thomas finisce per occuparsi solo del faro, proibendo a Ephraim di salirci sopra. La tensione, la solitudine e la stanchezza aumenta fin quando, arrivati alla fine della quarta settimana, una fortissima tempesta si abbatte sull’isolotto impedendo alla nave di venirli a prendere. Ormai senza più provviste, i due trovano una scorta di alcolici e finiscono per ubriacarsi di continuo generando ostilità, euforia e delirio. Quando l’isolamento diventa insostenibile, il tempo si dilata perdendo di significato, e la realtà diventa indistinguibile dalle allucinazioni, i due protagonisti finiscono per precipitare nella follia.
Ci sarebbe da dire tantissime cose su questo film. La storia è piena di metafore, simbolismi e riferimenti alla mitologia e alle leggende marine. Ho ritrovato l’abisso di Lovecraft, la follia dello Shining di Kubrick/King, il terrore degli Uccelli di Hitchcock. È un film estremamente psicologico dove il senso di colpa e il tema della sessualità è molto presente, l’elemento fallico del faro, la sirena ammaliatrice, le masturbazioni allucinogene di Ephraim.
La luce del faro potrebbe rappresentare la purezza della verità che porta alla pazzia. Il desiderio di Prometeo di rubare il fuoco degli dei e le conseguenze del suo gesto.
Stilisticamente il film è di una potenza visiva sconcertante, ogni inquadratura sarebbe da incorniciare. Girato in bianco e nero, in formato 4:3 in 35mm - e questa scelta contribuisce a fornire al film un’atmosfera claustrofica - fin dalle prime scene troviamo una forte matrice espressionista che omaggia in maniera esplicita i film degli anni trenta di Murnau e Fritz Lang. La colonna sonora affidata a Mark Korven è ossessiva e angosciante.
The Lighthouse è senza ombra di dubbio uno dei migliori film degli ultimi anni. Per me è un capolavoro ed è una vergogna che questo film non sia mai stato proiettato nelle sale per essere distribuito direttamente su Netflix.

Il buco
di Galder Gaztelu-Urrutia
L'horror e la fantascienza sono da sempre i miei generi preferiti e fortunatamente - in mezzo ai soliti film di supereroi ed effetti speciali che puntano più alla spettacolarità e all'intrattenimento - ogni tanto esce un film in grado di suscitare emozioni forti e inquietanti.
E' il caso del Buco, film dello spagnolo ed esordiente Galder Gaztelu-Urrutia che, dopo essere stato presentato in vari festival di genere accaparrandosi alcuni premi, approda su Netflix.
E' un film distopico, ansiogeno e claustrofobico che come tipologia potremmo accomunare a The Cube e sopratutto Snowpiercer in quanto in entrambi assistiamo a una sorta di esperimento sociale in cui i protagonisti sono rinchiusi in una struttura a livelli all'interno di uno spazio limitato.
Ci troviamo in una prigione a torre, strutturata verticalmente a livelli, centinaia di livelli. In ogni piano ci sono due prigionieri. Una volta al giorno una piattaforma scende di livello in livello attraverso un buco nel soffitto e nel pavimento di ogni cella portando il cibo ai prigionieri. Il cibo messo nella piattaforma sarebbe sufficiente per nutrire tutti i detenuti della torre ma quelli dei livelli superiori ne prendono di più, lasciandone ingiustamente di meno per quelli che sono sotto di loro. I disperati dei livelli inferiori sono così destinati a ricevere gli avanzi se non addirittura a morire di fame.
Nonostante ogni mese i detenuti vengano spostati di piano in maniera randomica - quindi i fortunati che si trovano ai piani superiori potrebbero ritrovarsi il mese successivo ai piani inferiori, e viceversa - non esiste collaborazione tra i prigionieri e l'avidità e l'egoismo domina tra di loro.
La metafora è tanto semplice quanto efficace e punta il dito contro la disuguaglianza sociale del sistema capitalista mostrandondoci tutta la brutalità dell’essere umano che non si pone limiti nel prevaricare l'altro per la propria sopravvivenza.
In alcune scene il regista ci va giù pesante non avendo paura di mostrare scene forti con l'intento di provocare il disgusto nello spettatore.
Il film funziona, gli attori sono bravi, ha una buona fotografia e ha la giusta tensione per tutta la sua durata. Peccato per il finale che risulta ambiguo e che lo colloca un gradino dietro a Snowpiercer (il film) che invece ha un finale più convincente