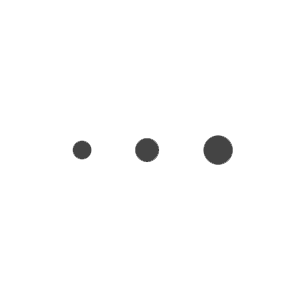Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
di Elio Petri
Un pugno nello stomaco. Dev'essere stato questo l'effetto di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto quando uscì nelle sale italiane nel 1970, in un periodo di forte tensione politica e sociale. Un opera scomoda, corrosiva, che rischiò la censura e il sequestro per la sua critica feroce alle istituzioni, in particolare alla polizia e al potere autoritario in Italia. Alla fine, il film di Elio Petri riuscì ad arrivare nelle sale, vincendo il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes e, l'anno successivo, l'Oscar come miglior film straniero.
Roma. Il capo della sezione omicidi (Gian Maria Volonté), proprio nel giorno della sua promozione all'ufficio politico, uccide l'amante Augusta Terzi (Florinda Bolkan). Invece di coprire le sue tracce, l'alto funzionario della polizia, che rimarrà senza nome, fa di tutto per seminare indizi che lo collegano al crimine, sfidando il sistema e mettendo alla prova fino a che punto il suo potere possa proteggerlo. Per quanto si sforzi di dare prove della sua colpevolezza, il sistema rifiuta di prenderle in considerazione. I suoi sottoposti, invece di sospettarlo, lo giustificano, lo proteggono, cercano spiegazioni alternative. Anche quando un testimone chiave, un idraulico, si trova davanti a lui e potrebbe incastrarlo, il timore reverenziale e il clima di omertà lo spingono al silenzio. Fino a che punto può spingersi un uomo investito di autorità? Quanto è disposto il sistema a proteggere se stesso, anche di fronte all'evidenza di un delitto?
Il racconto si dipana tra presente e flashback, dove emerge il rapporto morboso con Augusta, un gioco di potere e seduzione in cui lei lo sfida a dimostrare di essere un vero uomo, un'autorità assoluta. Una sfida che lo porterà a compiere l'omicidio e a usarlo come esperimento politico e socale.
Elio Petri costruisce un thriller psicoanalitico sull'abuso del potere che critica e analizza in chiave grottesca l'autoritarismo e l'impunità degli apparati polizieschi. Scritto dal regista insieme a Ugo Pirro, il film fece scalpore sopratutto nel nostro paese perchè uscì appena due mesi dopo la strage di piazza Fontana e la morte dell'anarchico Pinelli in un momento delicatissimo della storia italiana. Il film sembra anticipare il clima che avrebbe caratterizzato gli anni di piombo, con uno stato che si regge sulla repressione e su un potere che non sbaglia mai. È un film politico, profondamente legato al suo periodo storico, che unisce il tormento psicologico dostoevskiano alla visione grottesca e claustrofobica del potere tipica di Kafka.
Gian Maria Volonté è monumentale. Il suo personaggio è un uomo arrogante, sprezzante, con un accento marcato e un piglio tronfio che nasconde un'insicurezza profonda. La sua interpretazione è un continuo gioco tra delirio e lucidità, tra volontà di controllo e bisogno di autoumiliazione. E poi c'è la colonna sonora di Ennio Morricone, uno dei temi più famosi della sua carriera, un tango ambiguo con il mandolino iniziale che evoca l'origine siciliana del protagonista.
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è un film che non invecchia, anzi, con il tempo diventa ancora più inquietante. Il suo messaggio è chiaro: la giustizia non è uguale per tutti, e il potere può permettersi tutto, anche di uccidere alla luce del sole. E se nessuno osa fermarlo, forse il problema non è solo chi comanda, ma chi obbedisce senza farsi domande.
Film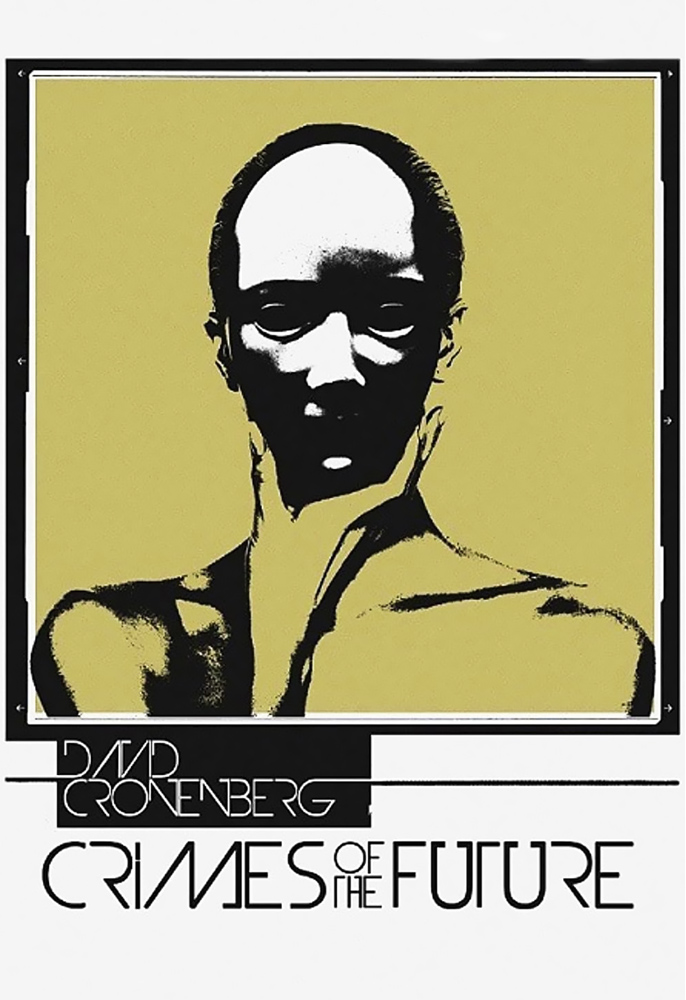
Crimes of the Future (1970)
di David Cronenberg
David Cronenberg è uno dei registi che più hanno segnato la mia passione per il cinema. Maestro indiscusso del body horror, ed esploratore instancabile delle mutazioni del corpo, il suo cinema è un virus che ha contaminato l’immaginario collettivo con visioni disturbanti e indelebili.
Nato a Toronto nel 1943, Cronenberg cresce in un ambiente stimolante – il padre era scrittore e giornalista – e si appassiona fin da piccolo alla letteratura, l'arte e la fantascienza. Durante gli anni universitari, scopre il cinema indipendente e inizia a sperimentare, girando i suoi primi cortometraggi a basso budget, Transfer (1966) e From the Drain (1967), dove già emergono i primi germogli del suo universo tematico.
Nel 1969 realizza il suo primo lungometraggio, Stereo, e l'anno successivo gira con un budget inesistente e un piglio sperimentale, Crimes of the Future, un film in cui sono già presenti tutte le ossessioni cronenberghiane come il contagio, la mutazione, la sessualità, e la tecnologia. È il manifesto primordiale di una poetica che, film dopo film, diventerà inconfondibile.
Siamo nel 1997. O meglio, in una sua versione distorta e post-apocalittica. La popolazione femminile del pianeta è stata spazzata via da un virus scaturito dall’uso incontrollato di prodotti cosmetici, un’infezione che prende il nome dal suo “creatore involontario”, il dermatologo Antoine Rouge. Nel mezzo di questa catastrofe, il suo ex pupillo, Adrian Tripod (Ronald Mlodzik), si aggira in un mondo senza femmine adulte nel quale i maschi mimano la gravidanza sviluppando nuovi organi che vengono successivamente amputati dai loro corpi.
Vedere Crimes of the Future non è stato facile. E' come sfogliare un quaderno di schizzi di un artista che sta ancora affinando il suo tratto. Cronenberg sperimenta senza filtri, facendo di necessità virtù. Girato quasi interamente all'interno di un edificio brutalista e senza audio in presa diretta – a causa del forte rumore della videocamera – il film è privo di dialoghi e suoni ambientali, con una voce fuori campo aggiunta in post-produzione. La voce di Tripod diventa così un elemento straniante, un diario di viaggio in un mondo malato, interrotto solo da rumori sintetici e disturbanti che sostituiscono una colonna sonora inesistente.
Il visionario futuro distopico raccontato da Cronenberg è reso attraverso simboli e concetti repulsivi come malattia, sessualità deviata, feticismo e pedofilia che, anche se non vengono tradotti in immagini esplicite, non sono meno disturbanti.
Certo, il film è grezzo, a tratti faticoso, con un minimalismo che può risultare respingente. È un'opera che consiglio solo ai cultori del regista canadese. Ma è affascinante proprio perché è Cronenberg allo stato puro, senza compromessi, che anticipa Il demone sotto la pelle e tutto il body horror che verrà. Qui non ci sono ancora le esplosioni di teste di Scanners o la carne che diventa metallo di Videodrome, ma c’è già il seme di tutto.
Se Cronenberg è un virus, Crimes of the Future è il primo contagio.

Terrore e terrore
di Gordon Hessler
Negli anni ’70, il cinema horror britannico cercava di reinventarsi, mescolando elementi tradizionali con nuove derive fantascientifiche e thriller. Terrore e terrore (Scream and Scream Again) è uno di questi tentativi, ma il risultato – diciamolo subito – non è proprio dei più riusciti.
Diretto da Gordon Hessler e tratto dal romanzo The Disorientated Man (1967), il film intreccia tre trame che sembrano viaggiare ognuna per conto proprio. A Londra, un uomo si risveglia in ospedale scoprendo, con orrore, di essere stato amputato. Nel frattempo, la polizia indaga su un serial killer che dissangua giovani donne. Altrove, in un regime totalitario non meglio identificato, un agente segreto elimina i suoi superiori con un inquietante tocco letale. Le indagini, guidate dal sovrintendente Bellaver (Alfred Marks), conducono al laboratorio del dottor Browning (Vincent Price), scienziato ossessionato dall’idea dell’uomo perfetto, che ha creato esseri artificiali per sostituire l’umanità.
L’idea di mescolare horror, poliziesco e fantapolitica poteva anche funzionare, ma qui tutto è dosato in modo confuso e approssimativo. La narrazione procede senza una vera direzione, le sequenze si dilatano oltre ogni ragionevolezza (su tutte, l’interminabile inseguimento di venti minuti) e il film, oltre che disordinato, a tratti diventa persino snervante.
La presenza in un unico film di Vincent Price, Christopher Lee e Peter Cushing – le tre leggende dell'horror britannico – in realtà è solo uno specchietto per le allodole in quanto solo il primo ha un ruolo di un certo rilievo, mentre Lee e Cushing appaiono brevemente e, peggio ancora, mai insieme. Un’occasione sprecata, proprio come il film stesso.
Film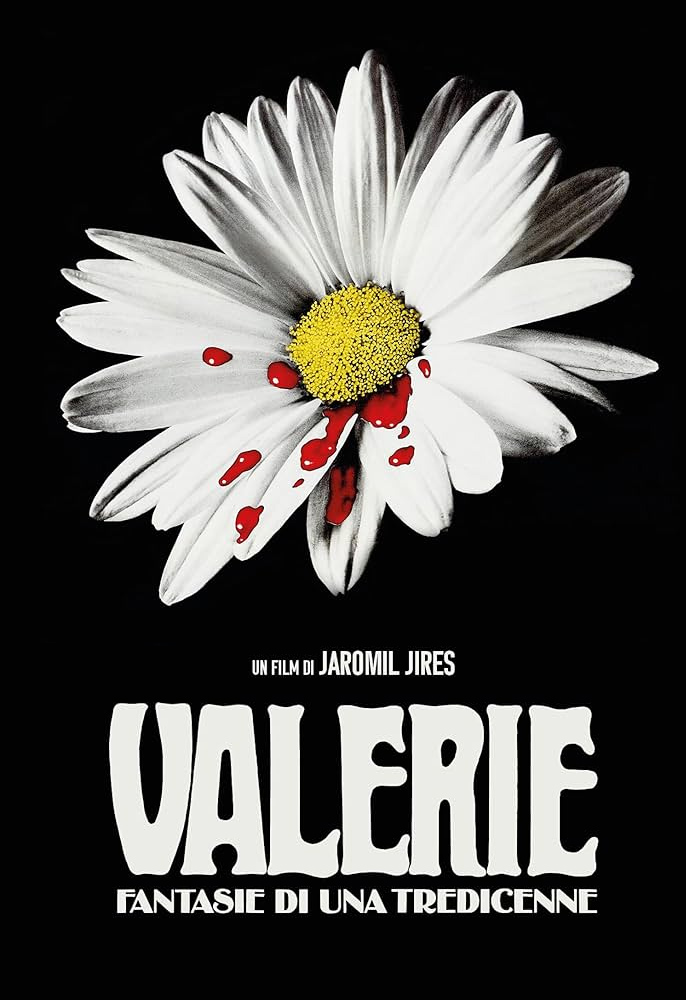
Valerie - Fantasie di una tredicenne
di Jaromil Jires
Se c’è un premio per il peggior titolo italiano mai affibbiato a un film, Fantasie di una tredicenne lo vincerebbe a mani basse. Il capolavoro di Jaromil Jireš, Valerie e la settimana delle meraviglie (Valerie a týden divu), è tutto fuorché il pornazzo da seconda serata che il titolo farebbe pensare. È un'opera visionaria e surreale, una favola nera in cui l’adolescenza si mescola con il terrore gotico, il vampirismo, il misticismo e un erotismo strisciante e perturbante, sempre sospeso tra il sacro e il profano.
Tratto dal romanzo di Vítezslav Nezval, poeta surrealista praghese, il film è una sorta di Alice nel paese delle meraviglie che racconta le avventure fantastiche di una tredicenne, che vive una settimana di eventi visionari, in un vortice di simbolismi, incubi e pulsioni sessuali. La protagonista, Valerie, interpretata dalla giovanissima Jaroslava Schallerová, è un’orfana che vive con la nonna in un piccolo villaggio ottocentesco. Tutto ha inizio con il suo primo ciclo mestruale, simbolicamente annunciato da una goccia di sangue su un fiore bianco. Da quel momento, la realtà si trasforma in un incubo, popolato da figure inquietanti e seducenti: un prete lussurioso e corrotto, un vampiro dal volto cadaverico che sembra volerla possedere, una nonna austera che, dopo un patto oscuro, si trasforma in una donna giovane e sensuale, e Orlík, un ragazzo misterioso che potrebbe essere il suo salvatore, il suo fratello, il suo amante – o forse tutte queste cose insieme.
Non c’è una trama vera e propria, non c’è consequenzialità negli eventi. Personaggi che muoiono e tornano in vita senza troppe spiegazioni, atmosfere rarefatte che sembrano oscillare tra sogno e realtà. Il tutto immerso in un'estetica fiabesca, con giochi di luce, veli bianchi e scenografie decadenti, accompagnate da una colonna sonora eterea e mistica.



Valerie e la settimana delle meraviglie – da adesso in poi lo chiamo con il suo nome internazionale – non è soltanto un trip visionario, una fiaba gotica che sembra uscita da un incubo dei fratelli Grimm. Prendendo ispirazione dal surrealismo di Luis Buñuel e Alejandro Jodorowsky, è anche una feroce critica alla società, dove il vampirismo si intreccia con il potere repressivo della Chiesa, vista come istituzione parassitaria, e con il desiderio dei vecchi di nutrirsi della giovinezza altrui.
Sorprendentemente, il film riuscì a sfuggire alla censura cecoslovacca, nonostante il rigido controllo del regime comunista sulla produzione artistica. Altrove, però, subì pesanti tagli, soprattutto per le sue tematiche sessuali e alcune scene di nudo della protagonista minorenne. Oggi è possibile recuperarlo integralmente su YouTube al seguente link, ma a una qualità decisamente scarsa.
Se cercate una storia lineare e comprensibile, Valerie e la settimana delle meraviglie non è il film adatto a voi. Chi invece adora lasciarsi trasportare dalle atmosfere oniriche e surreali – gli amanti del cinema di Lynch per esempio – scoprirà un’esperienza visiva che incanta e inquieta allo stesso tempo. Un piccolo capolavoro dimenticato, da riscoprire e vivere con con gli occhi di chi ancora sa stupirsi.

Vampiri amanti
di Roy Ward Baker
Negli anni Settanta, la Hammer – leggendaria casa di produzione inglese specializzata in horror gotici – iniziava a mostrare i primi segni di cedimento. Il barocco decadente che aveva ridefinito l'immaginario del genere stava lasciando il passo a un cinema dell'orrore più esplicito, violento e trasgressivo. La Hammer, però, non aveva nessuna intenzione di arrendersi, e con astuzia, offrì al pubblico esattamente ciò che chiedeva. Vampiri amanti (The Vampire Lovers) è un horror spiccatamente erotico che segna un punto di svolta nella produzione della casa britannica. Per la prima volta abbiamo vampiri dichiaratamente lesbici, in un'operazione audace per l'epoca, che alza il tiro su nudi, seduzione e ambiguità sessuale, senza rinunciare all'eleganza formale e al fascino delle ambientazioni gotiche.
Vampire amanti è il primo capitolo della trilogia hammeriana ispirata a Carmilla – il famoso racconto di Sheridan Le Fanu – a cui seguiranno Mircalla, l’amante immortale e Le figlie di Dracula, entrambi realizzati l’anno successivo. Il film segue la figura enigmatica e seducente di Mircalla Karnstein (Ingrid Pitt), una vampira che si insinua nella vita di giovani fanciulle con sguardi ammalianti e un'insaziabile sete d'amore e sangue. La sua prima vittima è Laura, figlia del generale Spielsdorf (Peter Cushing), che soccombe lentamente al fascino oscuro della creatura. Ma la morte di Laura non è che l'inizio. Sotto una nuova identità, Mircalla riappare come Carmilla e punta il suo sguardo sulla dolce e ingenua Emma (Madeline Smith), trascinandola in un vortice di fascinazione e terrore.
Vampiri amanti è un film che, pur essendo commerciale, cerca di svecchiare il gotico vampiresco in un modo quasi autoriale, imprimendo nel genere una maggiore morbosità. Scene di nudo, generosi décolleté e allusioni esplicite alla sessualità lesbo senza però rinunciare ai classici elementi dell’horror hammeriano con cripte, castelli e decapitazioni rituali.
Ottimo cast, dove gli uomini, compreso Cushing, restano in secondo piano per lasciare spazio ad aggraziate fanciulle ambigue e seducenti, tra cui spicca Ingrid Pitt che interpreta una Carmilla magnetica e letale, e la verginale e decisamente più attraente – almeno per i miei gusti – Madeline Smith.
Cult imprescindibile dell’horror vampiresco, il film unisce eleganza e trasgressione, mantenendo ancora oggi il suo fascino ambiguo e decadente.
Film
Il rosso segno della follia
di Mario Bava
Il rosso segno della follia, conosciuto anche con il titolo originale Un'accetta per la luna di miele, è un film di Mario Bava girato nel 1968 in Spagna ma distribuito solo nel 1970, dopo una travagliata lavorazione che includeva riprese aggiuntive e difficoltà di distribuzione. Ambientato a Parigi, nonostante le riprese siano avvenute tra Italia e Spagna e i personaggi portino nomi inglesi, il film fu prodotto da Manuel Caño e scritto da Santiago Moncada, autore prolifico del cinema di genere spagnolo. Malgrado Moncada si ispiri dichiaratamente ai grandi classici di Alfred Hitchcock, Mario Bava, che in questo film torna a occuparsi della fotografia, riesce a intervenire sul copione inserendo nella storia il personaggio di Laura Betti, attrice nota per aver lavorato con Fellini e Pasolini, che divenne il fantasma ironico e perfido che caratterizza il film.
La storia ruota attorno a John Harrington (Steve Forsyth), affascinante stilista e proprietario di un atelier di abiti da sposa. Dietro la facciata impeccabile si nasconde un paranoico assassino ossessionato da un trauma infantile mai risolto. Le sue vittime sono giovani spose, uccise con brutale precisione usando un’accetta. Quando, in preda al delirio, Harrington uccide anche la moglie Mildred (Laura Betti), il fantasma della donna inizia a perseguitarlo portandolo lentamente alla follia.
Riprendendo l'ambientazione di Sei donne per l'assassino, il film, visivamente, si distingue per la tecnica, l'ottima fotografia e l'eleganza delle inquadrature. Tuttavia, nonostante il suo indiscutibile valore estetico, Il rosso segno della follia non è il film più riuscito di Bava complice una sceneggiatura poco incisiva, una colonna sonora non memorabile e un cast (tolta la Betti) davvero imbarazzante - l'inespressivo attore protagonista pare imbalzamato.
Non mancano, però, momenti di brillante umorismo, come il passaggio dai fumi del crematorio a un toast bruciato, e citazioni metacinematografiche, come la scena in cui il protagonista guarda in televisione I tre volti della paura, altra opera di Bava.
Il rosso segno della follia fu un insuccesso al botteghino, oscurato dal debutto di Dario Argento con L'uccello dalle piume di cristallo. Il thriller di Argento, più violento e contemporaneo, catturava meglio i bisogni del pubblico dell'epoca. Fa sorridere pensare che in questo film di Bava si anticipa alcune delle tematiche e delle tecniche che Argento avrebbe ripreso e sviluppato in Profondo rosso: il trauma infantile legato a un fatto di sangue, la ripresa in soggettiva, i dettagli insistiti sulle armi, e persino la carrellata sui pupazzi, che Argento avrebbe sostituito con strumenti di morte dell'assassino.
Anche se oggi il film appare datato, rimane una testimonianza dello stile inconfondibile di un maestro che ha saputo creare la storia del thriller italiano ma che, probabilmente, per mancanza di autostima e di ambizione, è rimasto un artista con la mentalità di artigiano.
Film
L'uccello dalle piume di cristallo
di Dario Argento
Dario Argento non ha bisogno di presentazioni tra gli amanti del cinema di genere, ma ogni leggenda ha un inizio, e per il regista romano tutto comincia con L'uccello dalle piume di cristallo. Siamo nel 1970, un momento in cui il giallo italiano cerca una nuova identità. Figlio del produttore cinematografico Salvatore Argento e della fotografa Elda Luxardo, celebre per i suoi ritratti di dive italiane, Dario cresce immerso nel mondo dello spettacolo e del cinema. Prima di approdare dietro la macchina da presa, si afferma come giovane critico e sceneggiatore, collaborando con Sergio Leone per il soggetto di "C’era una volta il West".
Quando scrive la sceneggiatura di L’uccello dalle piume di cristallo - ispirandosi al romanzo giallo "La statua che urla" di Fredric Brown - Dario Argento non immagina che sarà lui stesso a dirigere il film. Tuttavia, innamoratosi della storia decide di fare il grande passo e debuttare come regista. Grazie all’appoggio del padre, che si unisce al progetto come co-produttore, Argento riesce a presentare il soggetto a Goffredo Lombardo, storico produttore della Titanus. Lombardo, entusiasta, accetta la sfida e dà fiducia a un esordiente che di lì a poco avrebbe cambiato per sempre il panorama del thriller italiano.
Con uno stile che gioca sul confine tra realtà e illusione, L'uccello dalle piume di cristallo è molto più di un film d’esordio: è il manifesto di una poetica che mescola eleganza visiva, suspence chirurgica e un gusto estetico inconfondibile. Nonostante Dario Argento abbia sempre respinto l’idea di essere stato influenzato da Mario Bava, è difficile non riconoscere alcune somiglianze con i capolavori del maestro, come "La ragazza che sapeva troppo" e "Sei donne per l’assassino". Dettagli come l’assassino con i guanti neri, il colpo di scena del doppio colpevole e l’uso della soggettiva sembrano suggerire un debito stilistico. Tuttavia, il film di Argento non è un’imitazione, bensì una reinvenzione, spiazzando lo spettatore con un raffinato gioco di prospettive e indizi. È il punto zero di un regista destinato a lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema.
La storia vede come protagonista Sam Dalmas (Tony Musante), un giovane scrittore americano, che assiste a un tentativo di omicidio in una galleria d’arte. Inizialmente i sospetti cadono su di lui, ma quando l'assassino lo prende di mira cercandi di ucciderlo, lo scrittore si improvvisa detective per cercare di risolvere il mistero e fermare la scia di sangue che terrorizza la città.
Con la sfrontatezza dell’esordiente convinto del proprio talento, Dario Argento si getta a capofitto nel genere giallo e ne rivoluziona l'approccio, intrecciando virtuosismi tecnici e una cura maniacale per l’estetica. Il risultato è un film che, pur basandosi su idee e atmosfere preesistenti, non solo sorprende per l’originalità della regia, ma pone le basi per un nuovo linguaggio cinematografico, capace di elevare il thriller italiano a livello internazionale.
Fin dal suo debutto, Argento introduce gli elementi distintivi del suo cinema come l’uso del punto di vista in soggettiva, primi piani su occhi e volti, un’ossessione per i dettagli e per la fotografia, trame ambientate in luoghi astratti e senza tempo, tocchi di ironia, personaggi grotteschi, moventi legati a profondi traumi, e una cura quasi rituale nella messa in scena degli omicidi. La macchina da presa diventa un personaggio a sé, muovendosi con soggettive immersive, zoom arditi, panoramiche vertiginose e angolazioni audaci. A completare questa visione innovativa, la fotografia magistrale di Vittorio Storaro, le ottime scenografie di Dario Micheli e la straordinaria colonna sonora di Ennio Morricone, che sottolinea l'importanza dell'elemento musicale nell’opera di Argento.
Il pubblico accolse il film con entusiasmo, premiandolo con un incasso al botteghino straordinario. Il successo di L'uccello dalle piume di cristallo non solo diede il via alla celebre trilogia degli animali, ma ispirò anche una lunga scia di imitazioni, consacrando Argento come il nuovo maestro del brivido.
Film