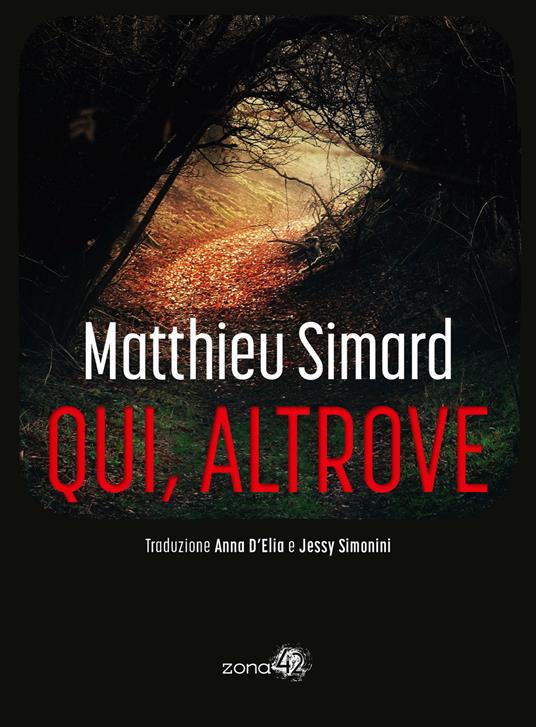
Qui, altrove
Matthieu Simard
Attirato dalla recensione del libro: "un romanzo dove il perturbante si incarna in un’atmosfera densa di enigmi e di mistero ...degna del miglior cinema di David Lynch", mi sono letto Qui, Altrove di Matthieu Simard, un romanzo breve pubblicato da Zona 42 nella sua nuova collana Caronte curata da Luigi Musolino, dedicata al lato più oscuro della narrativa fantastica.
Nel tentativo di fuggire da un passato doloroso, Marie e Simon decidono di trasferirsi in un paesino sperduto tra i boschi sperando di concepire un figlio e ritrovare la serenità perduta. Ma il paese non è il rifugio accogliente che speravano. Gli abitanti rimasti, segnati da un’esistenza ruvida e da segreti non detti, li accolgono con freddezza o con un’inquietante invadenza. Da quando la fabbrica locale ha chiuso e una misteriosa antenna è stata installata, il posto sembra aver assunto un’aura di sospensione irreale, come se qualcosa di indefinibile lo stesse corrodendo dall’interno.
Matthieu Simard, autore canadese, costruisce la tensione giocando tutto sulle atmosfere. La sua scrittura è scarna ma evocativa, capace di insinuare una sottile inquietudine nel lettore. Il romanzo si muove tra le voci di Marie e Simon, restituendoci un’immersione intima nei loro pensieri, nelle loro paure, nelle ferite ancora aperte che li accompagnano. Il villaggio in cui si stabiliscono è descritto come un luogo enigmatico e ostile, immerso in un silenzio irreale. L’assenza di suoni – il violoncello di Marie che non viene mai suonato, il canto degli uccelli che sembra essersi estinto – amplifica il senso di isolamento e perdita.
La prima parte procede con un ritmo lento, quasi ipnotico, scandito da giorni che si ripetono uguali e da interazioni cariche di ambiguità. Poi, nella seconda metà, le crepe si aprono e scopriamo i motivi della fuga di Marie e Simon, il loro dolore prende forma, e il loro comportamento inizialmente criptico assume un senso più nitido.
Qui, Altrove è un romanzo sospeso, costruito su un dolore mai dichiarato del tutto, su spazi vuoti che parlano più delle parole. Ci sono momenti di rara poesia, malinconici e struggenti, e l’atmosfera è senza dubbio riuscita. Eppure, alla fine, non mi ha convinto fino in fondo. Forse mi aspettavo qualcosa di meno etereo, più incisivo. È come se il romanzo sfiorasse continuamente il mistero senza mai afferrarlo del tutto. Rimane un’esperienza affascinante, ma anche elusiva, come un sogno che al risveglio ti lascia addosso solo un vago senso di inquietudine.
Libri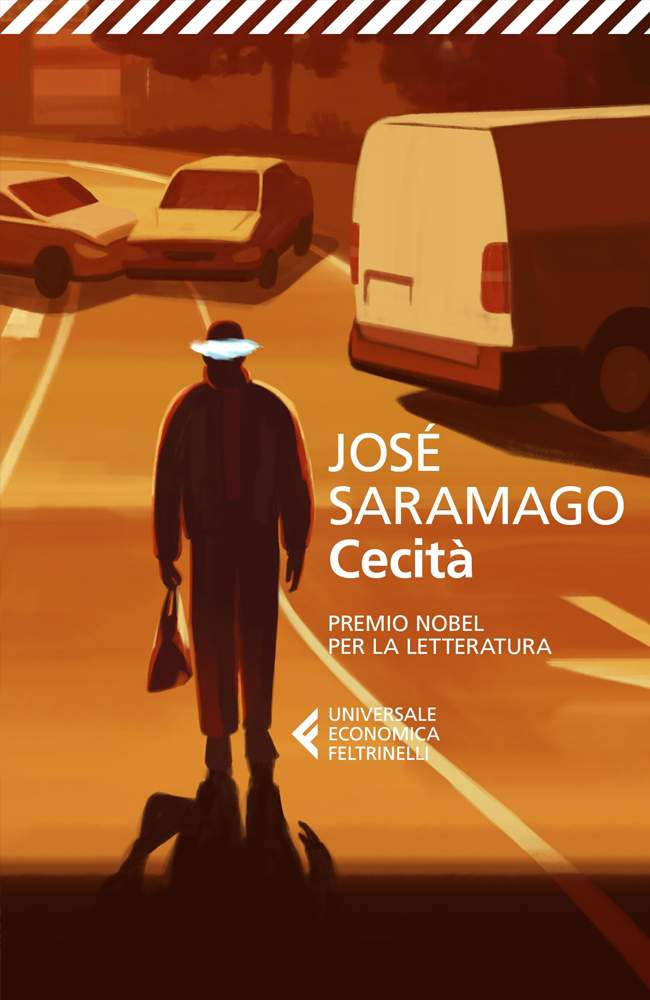
Cecità
José Saramago
Non avevo mai letto nulla di José Saramago prima d’ora, e devo dire che l’approccio al suo stile non è stato immediato. Ma di questo parlerò più avanti. Cecità, pubblicato nel 1995, è probabilmente il suo romanzo più noto, un'opera che lo ha portato a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il titolo originale, Ensaio sobre a Cegueira (Saggio sulla cecità), è stato modificato nella traduzione italiana per evitare che il libro venisse scambiato per un saggio filosofico.
Tutto ha inizio in un’anonima città quando un uomo, fermo al semaforo, diventa improvvisamente cieco. Ma non è un buio che lo avvolge, bensì un bianco lattiginoso, come se fosse immerso in una spessa nebbia. Poco dopo, chiunque entri in contatto con lui perde la vista allo stesso modo. Il medico che lo visita, i pazienti in sala d’attesa, la moglie del medico. Il contagio si propaga con una rapidità allarmante fino a costringere le autorità a intervenire. Per arginare l’epidemia, i primi ciechi vengono confinati in un ex manicomio sotto sorveglianza militare. Quello che dovrebbe essere un centro di contenimento si trasforma presto in un inferno: le regole del vivere civile crollano, emergono violenza, sopraffazione, fame e abbrutimento. L’umanità regredisce a uno stato primitivo, governata dalla legge del più forte. In questo scenario apocalittico, c’è una sola persona che ancora vede: la moglie del medico. Per ragioni inspiegabili, la cecità non l’ha colpita, e grazie alla sua vista cerca di guidare il piccolo gruppo con cui è rinchiusa, diventando una sorta di Virgilio in un girone infernale. Quando anche il mondo esterno soccombe all’epidemia, la città si trasforma in una landa desolata, popolata da ciechi che vagano alla ricerca di cibo, di riparo, di un senso in tutto questo caos.
Ammetto che inizialmente ho trovato difficoltà a entrare in sintonia con lo stile di Saramago. La sua prosa è assai particolare. Pochissimi a capo, periodi lunghissimi, nessun segno che indichi i dialoghi, solo virgole e punti per separare le frasi. Una scelta stilistica che può apparire ostica, ma che si rivela perfettamente coerente con la narrazione. I personaggi non hanno nomi, sono definiti solo dal loro ruolo (il medico, la moglie del medico, il primo cieco, la ragazza con gli occhiali scuri), quasi a suggerire che potrebbero essere chiunque. E anche il lettore, in un certo senso, diventa cieco, come se fosse costretto a "sentire" la storia più che a leggerla. La parte ambientata nel manicomio-lager è stata, per me, la più difficile da affrontare. Non perché non sia abituato a storie dure o a scenari estremi, ma perché Saramago non addolcisce nulla: la fame, la sporcizia, la violenza sessuale, la lotta per il potere emergono con una crudezza spietata, senza filtri. Ci sono momenti in cui il romanzo diventa soffocante, quasi insopportabile, ma proprio in questo sta la sua forza. È un libro che mette a disagio, che spinge a guardare in faccia il lato più oscuro dell’umanità. Nonostante tutto, in questo incubo collettivo, ci sono anche lampi di luce: gesti di solidarietà, attimi di umanità che resistono al degrado. La moglie del medico, con la sua vista, non è solo un testimone del crollo della civiltà, ma anche una guida, una speranza. E il finale, con quella frase potentissima – "secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo ciechi, ciechi che, pur vedendo, non vedono" – lascia il lettore con una domanda aperta: forse la cecità più spaventosa non è quella fisica, ma quella morale?
Cecità non è un libro semplice né confortante. È disturbante, viscerale, in certi passaggi persino respingente. Ma è anche un libro capace di scuotere e di far riflettere. Sicuramente difficile da dimenticare.
Libri
Fiori per Algernon
Daniel Keyes
Non conoscevo Fiori per Algernon. Eppure è in circolazione da più di mezzo secolo, ha vinto numerosi premi, ispirato adattamenti cinematografici e viene spesso definito un romanzo di fantascienza – anche se trovo questa etichetta riduttiva, quasi fuorviante. Mi è stato regalato e, una volta terminata la lettura, ho sentito il bisogno di ringraziare chi mi ha fatto scoprire questo gioiello.
Il libro è stato scritto da Daniel Keyes, psicologo e docente statunitense impegnato nel sostegno a ragazzi con difficoltà di apprendimento. Pubblicato nel 1966, nato inizialmente come racconto breve, il libro è una sorta di moderno Frankenstein che ti porta a una profonda riflessione e ti lascia addosso una malinconia difficile da scrollarti di dosso.
La storia è quella di Charlie Gordon, un uomo di circa trent'anni con disabilità intellettiva che lavora in una panetteria e sogna di essere "normale". I suoi desideri sono semplici: essere accettato, avere amici, capire il mondo come gli altri. Quando gli viene offerta la possibilità di sottoporsi a un intervento sperimentale che promette di aumentare il suo quoziente intellettivo – un'operazione già testata con successo su Algernon, un topo da laboratorio – Charlie accetta senza esitazione. Dopo l'operazione, le sue capacità mentali crescono rapidamente, trasformandolo in un genio. Tuttavia neanche il nuovo, sempre più elevato quoziente intellettivo aiuta il protagonista ad ottenere l’amicizia che desiderava. Al contrario, la consapevolezza di ciò che è stato non fanno altro che esaperare il suo isolamento, accentuato dal fatto che ora l’uomo capisce e ricorda episodi del passato, prima da lui incompresi.
Il romanzo è narrato attraverso i rapporti di progresso scritti dal protagonista, una sorta di diario che riflette la sua trasformazione. All'inizio i resoconti sono pieni di errori grammaticali e ingenuità, ma dopo l'esperimento la scrittura si fa più precisa, complessa ed emotiva. Charlie non solo comprende il mondo con occhi nuovi, ma lo analizza, lo scompone, lo giudica. Il problema è che la sua intelligenza, che lo porta a superare i suoi stessi creatori, non va di pari passo alla sua emotività. La consapevolezza che le persone che considerava amici ridevano di lui, lo sfruttavano, lo compativano, gli stessi genitori che non l'hanno mai accettato, ora si rivela con una lucidità dolorosa. E, anziché sentirsi più vicino agli altri, Charlie si ritrova più solo che mai.
Quando Algernon inizia a mostrare i primi segni di regressione, Charlie capisce che il suo destino è segnato. La presa di coscienza della propria inevitabile discesa, la consapevolezza che l’intelligenza sta sfumando, fino a regredire ad un livello ancora inferiore rispetto a quello originaria, è il momento più straziante e commovente del romanzo.
Fiori per Algernon è un libro che illumina e ferisce con la stessa intensità. Una storia che lascia il segno e che consiglio vivamente. Peccato per la copertina di questa edizione. Davvero brutta.
Il libro di Keyes ha avuto un adattamento cinematografico intitolato I due mondi di Charlie, film del 1968 diretto da Ralph Nelson.
Libri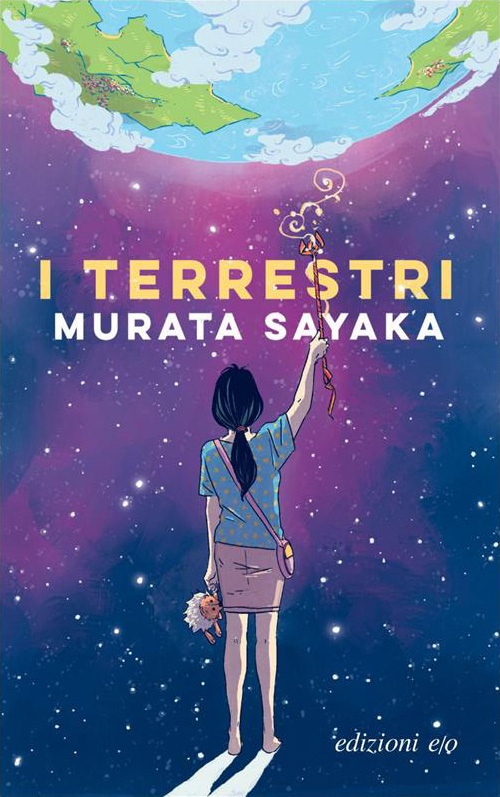
I terrestri
Murata Sayaka
Murata Sayaka è una scrittrice giapponese autrice del bestseller La ragazza del convenience store. Non l'ho ancora letto ma conto di farlo in un prossimo futuro.
Mi sono avvicinato a questo romanzo senza conoscere l'autrice e senza sapere cosa aspettarmi. Leggendo la sinossi del libro e guardando la copertina uno si aspetterebbe di leggere una storia con protagonista una sorta di Lamù o Sailor Moon. Niente di più sbagliato.
Natsuki è una ragazzina di undici anni convinta di essere una maga e di possedere dei poteri magici grazie a un portacipria e una bacchetta donati da un pupazzo di peluche chiamato Piyut proveniente dal pianeta Pohapipinpobopia. Natsuki vive con i suoi genitori e una sorella capricciosa ed egoista di un paio di anni più grande. La madre sembra nutrire affetto solo per la primogenita riversando su Natsuki tutte le sue frustrazioni e amarezze. Il padre è assente e la sua presenza si limita solo nell'infliggergli punizioni. Costantemente criticata e umiliata dai suoi genitori Natsuki sembra trovare un motivo di esistere solo nel suo mondo fantastico.
Ogni estate la famiglia si riunisce insieme a tutti i fratelli e cugini nella casa dei nonni paterni tra le montagne di Akishina per la festa degli Obon (la festa giapponese che commemora e ricorda i defunti). Questo è l'unico luogo in cui Natsuki si sente felice perchè ha l'occasione di condividere le sue fantasie con il cugino coetaneoYuu, un ragazzo che proviene da una famiglia disagiata convinto di essere un extraterrestre in attesa che qualcuno lo porti sul suo pianeta d'origine. Nei mesi successivi Natsuki subisce degli abusi sessuali da parte del suo insegnante - non venendo creduta dalla madre che l'accusa di voler attirare l’attenzione - e il suo corpo reagisce perdendo prima il gusto e poi l’udito da un orecchio. L'estate successiva Natsuki e Yuu si ritrovano e il loro legame profondo viene sugellato da un "matrimonio" segreto comprensivo di rapporto sessuale che, non appena scoperto, scatena l'ira degli adulti, segna una rottura tra le loro famiglie e porta alla loro separazione.
Nella seconda parte del romanzo ritroviamo Natsuki, ormai trentenne, sposata con Tomohiko, personaggio ancora più dissociato convinto che gli individui sono ingranaggi di una grande fabbrica che li obbliga a lavorare e generare figli.
Non vado oltre perchè il romanzo, sopratutto nel finale, prende una piega inaspettata e degenerativa alquanto inquietante.
Il romanzo di Murata Sayaka sembra in superficie una fiaba (che sfocia nell'orrore) con protagonista una moderna Cenerentola ma in realtà è una critica feroce nei confronti della società giapponese che emargina coloro che non sono allineati e non seguono le regole (istruzione, lavoro, matrimonio, figli) facendoli sembrare dei veri e propri alieni, al cospetto de "i terrestri". Stiamo parlando del malessere sociale che da tempo dilaga in Giappone, e che per certi versi si può riscontrare anche in occidente, di una generazione oppressa nel dimostrare di essere all'altezza del modello sociale che gli viene imposto e che li vuole tutti belli, felici e vincenti.
Natsuki, Yuu e Tomohiko, entrambi traumatizzati dalle loro famiglie, decidono di infrangere queste regole eliminando tutti i limiti imposti dalla società, e nel cercare la loro via di fuga e ribellione finiscono per perdere ogni tipo di inibizione e... umanità, d'altra parte sono alieni.
Un romanzo provocatorio che parla di disagio e diversità. Suggestivo, sconcertante e parecchio straniante.
