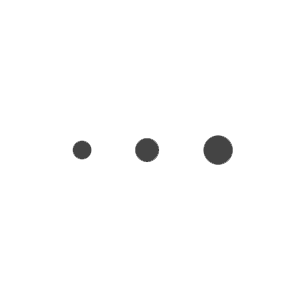The Studio
Seth Rogen, Evan Goldberg
Ho adorato Boris, la serie che prendeva in giro la mediocrità delle produzioni televisive italiane con cinismo, sarcasmo e irriverente intelligenza. Quando ho sentito parlare di The Studio, serie televisiva di Apple TV+ ambientata nel mondo dell'industria cinematografica hollywoodiana, l'associazione alla mitica serie con Pannofino e compagni è stata immediata. Il "Boris americano", ho letto da più parti. Ovviamente, vedendo i dieci episodi, le analogie finiscono rapidamente, perché stiamo parlando di due realtà completamente diverse. In Boris il regista René Ferretti, il giovane stagista Alessandro, e tutti gli attori e tecnici impegnati a realizzare fiction di dubbio gusto fatte "a cazzo di cane" con quattro spicci nei capannoni di Cinecittà, vivono continuamente di compromessi, mediocrità, precarietà lavorativa e senso di rassegnazione. The Studio è invece ambientata nella sfavillante, ricca e autoreferenziale Hollywood contemporanea, con celebrità che interpretano se stesse, macchine di lusso, ville a Beverly Hills e budget da capogiro. Mondi agli antipodi, eppure uniti da un filo sottile: la consapevolezza che il sistema dell'intrattenimento, qualunque esso sia, è una macchina paradossale dove l'arte e il business convivono in un equilibrio precario, spesso grottesco.
The Studio è scritta e diretta da Seth Rogen, che interpreta anche il protagonista, ed Evan Goldberg, due autori affermati nell'ambito della commedia hollywoodiana con tanti film all'attivo e una collaborazione che dura da anni. Non li conoscevo – la commedia di facile consumo non è propriamente il mio genere preferito – ma la satira e i racconti che scavano dentro l’industria cinematografica mi hanno sempre affascinato.
The Studio segue le tragicomiche vicende di Matt Remick (interpretato dallo stesso Rogen), un produttore che ha fatto gavetta per vent'anni nei Continental Studios e che improvvisamente si ritrova promosso a capo dello studio. La sua mentore Patty Leigh (Catherine O'Hara) è stata silurata dal nuovo CEO (Bryan Cranston) e Matt si ritrova a ereditare non solo la poltrona, ma anche una missione impossibile: tenere in piedi uno studio in crisi, far quadrare i conti e, se possibile, produrre film che abbiano ancora un senso artistico. Il problema è che Matt è un cinefilo autentico, uno che sogna di fare "cinema d'autore" ma che deve invece dare il via libera a un film sul pupazzo della Kool-Aid, nel disperato tentativo di replicare il caso Barbie.
La serie ci accompagna episodio dopo episodio attraverso i suoi tentativi goffi e disastrosi di tenere in piedi questa impossibile quadratura del cerchio: da una parte le pressioni di Griffin che vuole fare soldi a palate, dall'altra il suo disperato bisogno di dare un senso artistico a tutto quello che tocca. Ogni puntata è una piccola catastrofe. Matt prova a coinvolgere Martin Scorsese in un progetto improbabile salvo poi dovergli dare il benservito, si intrufola sul set di Sarah Polley causando disastri durante un piano sequenza (peraltro la serie fa grande uso di piani sequenza), deve dire a Ron Howard che il finale del suo film va accorciato, affrontando un trauma mai risolto. Il tutto in un crescendo di equivoci, imbarazzi e situazioni surreali che restituiscono l’idea di un sistema sempre sull’orlo del collasso.
Intorno a lui si muove un cast di ottimi comprimari: il vice cinico e opportunista Sal (Ike Barinholtz), la responsabile marketing Maya (Kathryn Hahn), l’ambiziosa assistente Quinn (Chase Sui Wonders). E poi ci sono loro: le guest star. Perché The Studio è anche e soprattutto un grande gioco di camei, con attori e registi che interpretano versioni esagerate e autoironiche di se stessi. Oltre ai già citati Scorsese, Howard, Polley e Lee, sfilano Zoë Kravitz, Anthony Mackie, Charlize Theron, Olivia Wilde, Zac Efron, Ice Cube, Steve Buscemi, Adam Scott e molti altri.
Al di là di qualche episodio meno centrato, The Studio è una parodia intelligente che funziona su più livelli, riescendo a essere insieme una lettera d'amore al cinema e una denuncia spietata dei meccanismi che lo stanno uccidendo. Rogen e Goldberg mettono in scena tutte le contraddizioni del cinema contemporaneo: l’ossessione per i franchise, le pressioni degli algoritmi e dello streaming, i discorsi sull'inclusività trasformati in operazioni di marketing, le Big Tech pronte a fagocitare Hollywood. È una satira brillante e maliconica che non ride dei personaggi, ma con loro. Il protagonista, Matt, diventa così simbolo di una generazione sospesa tra amore sincero per il cinema e la consapevolezza che il sistema è irrimediabilmente intrappolato in meccanismi ripetitivi e spesso distruttivi. Eppure, quando tutto si allinea e nasce un bel film, come dice Patty, "è per sempre". E questa speranza, per quanto fragile, vale ancora la pena di essere coltivata.
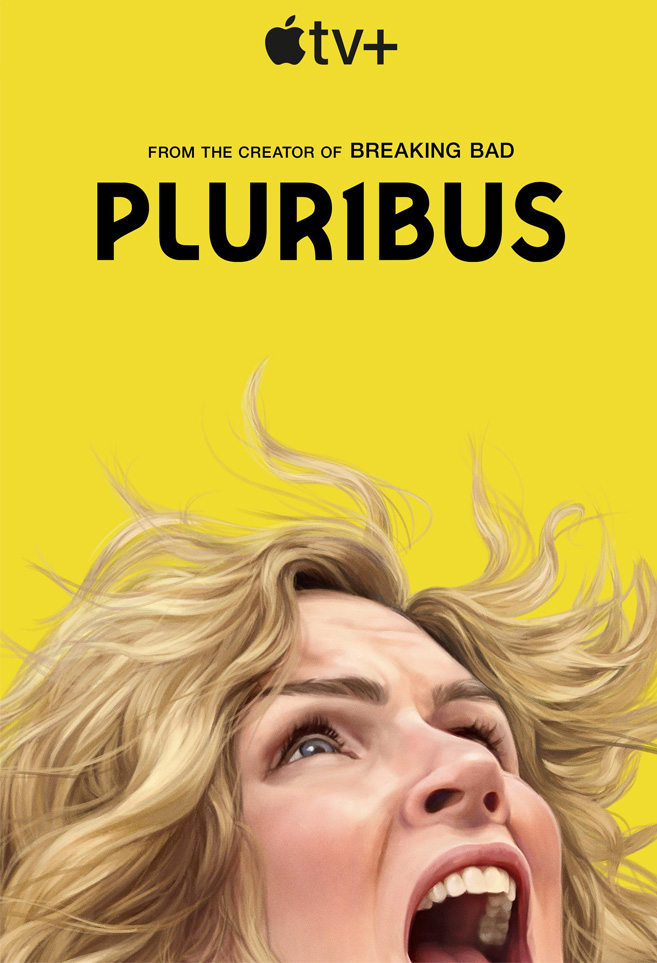
Pluribus
Vince Gilligan
Niente da fare. Apple TV+ si dimostra ancora una volta sinonimo di qualità puntando su Vince Gilligan. Dopo aver esplorato ogni angolo oscuro dell’animo umano tra metanfetamine e raggiri legali, il creatore di Breaking Bad si tuffa con Pluribus in una fantascienza inquietante e profondamente filosofica. Una scommessa che si è rivelata vincente, visto che la serie è diventata la più vista nella storia della piattaforma.
In Pluribus un misterioso segnale proveniente da seicento anni luce di distanza viene captato dagli scienziati della Terra. È l’origine di un virus galattico che in breve tempo trasforma l’umanità in una mente collettiva, un’unica entità serena, pacifica e terribilmente felice. In questo scenario seguiamo Carol, interpretata da una grandissima Rhea Seehorn, una delle sole tredici persone al mondo rimaste immuni e ancora in possesso della propria coscienza individuale. Carol è una scrittrice frustrata ma famosa per i suoi romanzi fantasy di successo, misantropa, scontrosa, cinica e sospettosa. Vive isolata su una collina con una splendida vista su Albuquerque, la città feticcio di Gilligan. Ha perso la propria compagna e ora si ritrova circondata da miliardi di esseri umani trasformati in una versione inquietante dei testimoni di Geova. Sempre sorridenti, sempre gentili, sempre pronti a convincerti che unirsi all’alveare sia l’unica via per la vera felicità. Apparentemente privi di emozioni negative, questi nuovi esseri umani convivono con un dilemma morale che viene svelato nel corso degli episodi e che diventa il vero fulcro della narrazione. Tra i resti di una società in cui la serenità collettiva sa di anestesia, Carol combatte per la propria individualità, decisa a salvare il mondo dalla felicità.
È proprio su questo paradosso che Pluribus costruisce la sua forza. Gilligan prende uno dei desideri più profondi e universali dell’essere umano, quello di essere felice, e lo trasforma in una minaccia. La felicità che permea il mondo dopo il contagio non è conquistata, non è il risultato di un percorso, ma un’imposizione dolce, sorridente, irrevocabile. Un’utopia che odora di distopia, dove il conflitto non viene eliminato ma semplicemente rimosso, insieme al dolore, alla rabbia, al dubbio e infine alla libertà.
Pluribus è un drama thriller psicologico e filosofico di estrema sottigliezza e intelligenza. Non è una serie mainstream, non ci sono esplosioni, inseguimenti o adrenalina a buon mercato. Non è un prodotto pensato per chi vuole staccare il cervello. È una serie adulta, densa, che richiede attenzione e pazienza. La sua lentezza, la dilatazione dei tempi, diventano una precisa scelta stilistica che permette di entrare nella mente di Carol, un’antieroina in costante subbuglio, costretta a ricalibrare di continuo la propria percezione della realtà. Il contrasto tra la tranquillità alienante del mondo esterno e il tumulto interiore della protagonista genera una tensione narrativa ricca di stravolgimenti, rivelazioni e di un umorismo nero sottilissimo. In questo senso Rhea Seehorn regge l’intera serie con una performance straordinaria, misurata e intensissima. Accanto a lei convince anche Karolina Wydra nel ruolo di Zosia, accompagnatrice di Carol e presenza ambigua, sempre gentile e disponibile. Non è semplice incarnare una serenità costante senza scivolare nell’artificio. Altrettanto efficace è Carlos Manuel Vesga nei panni di Manousos, il paraguayano dalla morale ferrea senza compromessi che incarna la ribellione, l’urgenza assoluta di sconfiggere gli “Altri” e salvare il mondo a qualunque costo.
Gilligan, prendendo spunto da classici come L'invasione degli ultracorpi del 1956 e da Ai confini della realtà, solleva domande filosofiche profonde. Cosa significa davvero essere umani? La libertà vale più della serenità? Eliminare il conflitto significa anche eliminare ciò che ci rende individui? Questioni che riecheggiano temi estremamente attuali, dall’intelligenza artificiale e la minaccia che potrebbe rappresentare per l'individualità, fino al desiderio contemporaneo di comunità perfette dove il dissenso non trova spazio.
Alla fine Pluribus non parla di alieni, virus o fantascienza, ma di scelte. Di quanto sia fragile il confine tra benessere e annullamento, tra armonia e controllo. Perché la domanda che la serie pone, episodio dopo episodio, è semplice e disturbante. Siamo davvero disposti a rinunciare a ciò che ci rende umani pur di non soffrire più.
Quest’anno ho visto poche serie televisive, ma senza ombra di dubbio, insieme a Adolescence e Scissione, Pluribus è una delle migliori. Un’ulteriore conferma che quando Apple TV+ decide di investire in un progetto, raramente sbaglia. E che Vince Gilligan, anche lontano dall’universo di Walter White, sa ancora come sorprendere e inquietare in egual misura.
Serie TV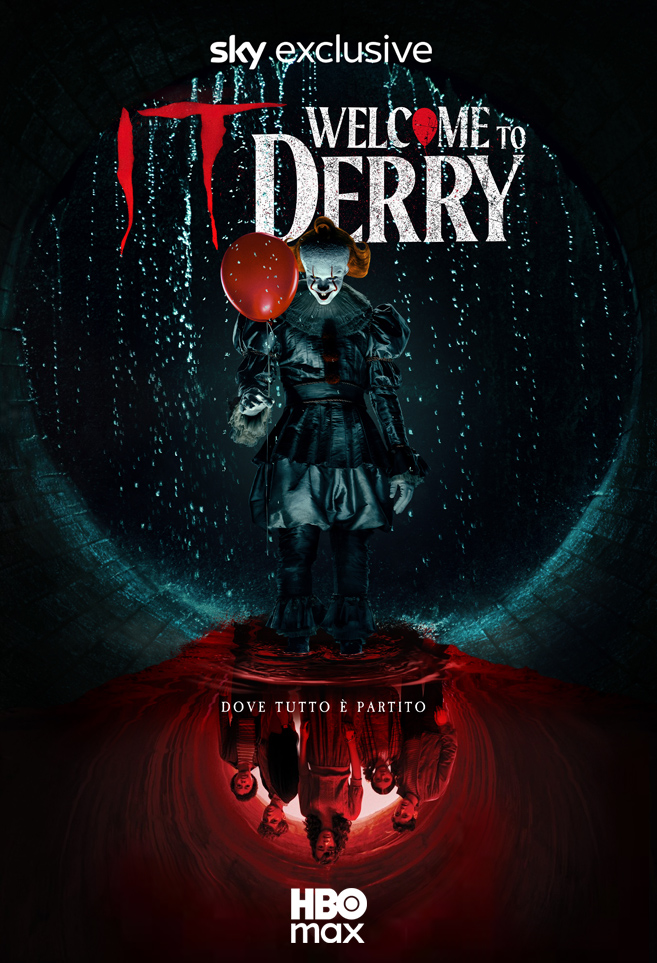
It - Welcome to Derry
Andy Muschietti
Sono tornato a vedere una serie televisiva dopo parecchio tempo. Anzi, insieme a questa ne sto seguendo anche un’altra che deve ancora concludersi, ma di quella parlerò in un altro post. Ora concentriamoci su It: Welcome to Derry.
Quando venne annunciato che Andy Muschietti avrebbe prodotto una serie prequel dei suoi due film di successo su It, la reazione collettiva fu più o meno un sospiro rassegnato. Ecco, avranno pensato in molti, l’ennesimo spin-off destinato a spremere il franchise fino all’osso, nel tentativo di replicare il mega successo di Stranger Things (a sua volta ispirata proprio a It). Prodotta da HBO e distribuita in Italia da Sky Atlantic, la serie è composta da otto episodi ed è ambientata nel 1962, con l’obiettivo di raccontare quella che dovrebbe essere l’origine del male nella cittadina più maledetta d’America.
Prima di proseguire faccio una doverosa premessa.
Non sono un cultore della saga di It. Il romanzo l'ho letto da adolescente, come quasi tutti i King di quegli anni, e con il tempo mi è rimasta solo la sensazione vaga di un'opera complessa, stratificata, avvincente. Non ho visto nemmeno i due film recenti di Muschietti. E nutro, lo ammetto senza vergogna, un fastidio per quelle serie in cui gruppetti di ragazzini in bicicletta devono sconfiggere il male che si annida nella loro cittadina. Ogni riferimento a Stranger Things non è assolutamente casuale.
Fatte queste premesse - e agli amanti del genere chiedo anticipatamente scusa - ci andrò giù duro.
Ma prima l'immancabile sinossi.
Siamo a Derry, all’inizio degli anni Sessanta. Un’America sorridente come una pubblicità, attraversata dalle paranoie della Guerra Fredda e da un razzismo che continua a scorrere sotto la patina della rispettabilità borghese. In città arriva un pilota dell’aeronautica, assegnato a una missione segreta, insieme alla sua famiglia. Quasi in parallelo iniziano misteriose sparizioni di bambini. Un gruppo di ragazzini - i predecessori del futuro Club dei Perdenti - decide di indagare. Nel frattempo Dick Hallorann, un soldato dotato di poteri di chiaroveggenza – lo stesso personaggio di Shining – percepisce, grazie alla sua "luccicanza", l’entità malefica che si nasconde sotto la superficie della città.
È piuttosto evidente che Welcome to Derry voglia parlare al vasto pubblico, quello in cerca dell'orrore a buon mercato, cavalcando un immaginario già collaudato. Un horror accessibile, fatto di spaventi e scene a effetto. Nulla di male. Il problema? Questa serie non fa paura. Ma proprio per niente. Non c'è un singolo momento di autentica tensione in otto episodi.
Certo, è girata bene. Patinata, confezionata con cura, una buona fotografia. Ma tutto è maledettamente prevedibile. Anche le scene che dovrebbero essere di puro orrore, appaiono posticce, quasi ridicole. La CGI non è proprio il massimo e a tratti sembra di assistere a un cartone animato più che a qualcosa che dovrebbe terrorizzarti.
E poi ci sono i ragazzini. Probabilmente è un problema mio, lo ammetto, ma mi risultano indigesti. Tutti. In particolare la protagonista che interpreta Lilly, con quelle faccia perennemente piagnucolosa che ti fa venire voglia che prima o poi le creatura se la divori. Niente da fare, ovviamente non accade.
Tante scene a effetto, momenti strappalacrime preconfezionati e un finale tirato via come se gli sceneggiatori avessero esaurito le idee e avessero deciso di chiudere in fretta e furia.
Poi, per carità, qualcosa si salva. La scena dell'incendio al Black Spot, il locale dei soldati afroamericani, è riuscita bene, ha un peso drammatico reale. Alcuni flashback sulle origini di Pennywise sono interessanti. Ma il resto? A volte i comportamenti dei personaggi non hanno né senso né scopo narrativo, e poi quella "geniale" idea che Pennywise possa viaggiare nel tempo. Ma davvero? Era necessario? L'orrore cosmico e indefinibile di King aveva bisogno di questa spiegazione da fumetto di terza categoria?
Forse sono io troppo esigente. O forse, più semplicemente, sono fuori target.
Diciamo che ho maturato una certa insofferenza per le serie televisive, quella tendenza a dilatare tutto, ad aggiungere scene, subplot, momenti che in una pellicola cinematografica verrebbero giustamente sforbiciati. È l'allungamento del brodo narrativo pensato apposta per consentire il binge-watching, per farti consumare bulimicamente una puntata dopo l'altra fino alle tre del mattino, non perché la storia lo richieda, ma perché l'algoritmo lo esige.
It: Welcome to Derry è l'esempio perfetto di questa logica, una storia che avrebbe potuto essere un film di due ore, tirata fino a otto episodi. È una serie che funziona se accetti di spegnere il cervello e goderti lo spettacolo superficiale. Se invece vuoi qualcosa che ti rimanga dentro, che ti inquieti davvero, che ti faccia pensare... beh, forse è meglio ripescare il romanzo di Stephen King e rileggerselo.
Serie TV
L'Eternauta
Bruno Stagnaro
Fin da quando hanno cominciato a circolare le prime voci su un adattamento televisivo de L'Eternauta, ho provato un misto di curiosità e scetticismo. Per me – e per molti altri – si tratta di un’opera intoccabile, un capolavoro del fumetto del ventesimo secolo, non solo per il suo valore narrativo ma soprattutto per il suo peso simbolico e politico. L’idea che potesse essere trasformata in una serie Netflix, magari omologata alle solite estetiche post-apocalittiche, mi lasciava più di una perplessità.
Ho conosciuto L’Eternauta quando ero poco più di un bambino, sfogliandolo sui vecchi albi di Lancio Story che trovavo in casa. All’epoca non ne comprendevo pienamente la portata – ero ancora rapito dai supereroi colorati della Marvel, quelli pubblicati dall’Editoriale Corno – ma quelle tavole mi lasciavano addosso un senso di inquietudine e meraviglia. Solo anni dopo, in età adulta, l’ho riscoperto in volume, leggendolo per intero e rendendomi conto – anche alla luce della storia personale del suo autore e del contesto politico dell’Argentina – di quanto fosse un’opera profonda e stratificata.
Pubblicata a puntate tra il 1957 e il 1959 sulla rivista Hora Cero, L’Eternauta nasce dalla penna di Héctor Germán Oesterheld e dalle matite di Francisco Solano López. È un fumetto di fantascienza post-apocalittica, forse il capostipite dell’Historieta argentina, quella corrente fumettistica che tra gli anni cinquanta e ottanta ha prodotto opere memorabili. In quel racconto cupo e visionario, Oesterheld intercetta le tensioni politiche dell’epoca e, con inquietante preveggenza, utilizza una misteriosa invasione aliena come metafora del sorgere di un regime autoritario che annienta ogni forma di dissenso.
Diversi anni dopo la pubblicazione de L'Eternauta, l’Argentina cadde davvero sotto una feroce dittatura militare. Migliaia di oppositori furono arrestati, torturati, fatti sparire. Tra le vittime, lo stesso Oesterheld – ormai attivista politico – e le sue quattro figlie, tutte sequestrate e uccise da squadre armate.
Conoscendo questa storia, diventa impossibile leggere L’Eternauta come un semplice fumetto di genere. È un’opera che grida resistenza e che denuncia l’oppressione. Ecco allora che torno alla mia perplessità iniziale. Ha senso riproporre oggi una storia scritta più di sessant’anni fa così radicata nel suo tempo e nel suo luogo? Guardando il mondo di oggi, con i suoi nuovi autoritarismi, le guerre alle porte dell’Europa, la striscia di Gaza e il risorgere di vecchi fantasmi, la risposta sembrerebbe ovvia. Ma quanto i produttori saranno davvero capaci di interpretare questa chiave, e quanto invece si limiteranno a offrire l’ennesima distopia da catalogo?
La serie è composta da sei episodi ed è ambientata a Buonos Aires ai giorni nostri. E' una produzione argentina a tutti gli effetti, prodotta, sceneggiata e diretta da Bruno Stagnaro. Il protagonista, Juan Salvo (interpretato da Ricardo Darín), si trova a casa con un gruppo di amici quando un improvviso black-out precede una misteriosa nevicata che inizia a cadere sulla città. Ben presto si capisce che non è neve, ma una sostanza tossica capace di uccidere all’istante chiunque venga esposto. In un primo momento Juan e i suoi amici cercano di unire le forze per salvarsi e proteggersi, poi, dopo aver costruito delle rudimentali tute per potersi muovere all’esterno, nel cercare di comprendere l’origine di questa letale minaccia, scoprono che la nevicata è solo l’inizio di un’invasione aliena pianificata e stratificata.
La serie mantiene un ritmo lento e riflessivo, decisamente lontano dai canoni dell’action che siamo abituati a vedere. Ma questo, almeno per quanto mi riguarda, non mi disturba. L’atmosfera sospesa e di attesa, rispecchia bene la tensione del fumetto originale. L’elemento più interessante resta forse proprio la scelta di raccontare l’apocalisse da un punto di vista umano e intimista. Il protagonista è un uomo qualunque, un eroe per caso, in bilico fra i suoi affetti, misteriose visioni, e la necessità di sopravvivere in un mondo diventato improvvisamente ostile. La recitazione è buona, la fotografia efficace, soprattutto nei momenti in cui Buenos Aires diventa un deserto bianco, silenzioso e mortale. Anche le creature e gli effetti speciali – pur senza strafare – risultano convincenti.
Il problema principale della serie è che sembra prevedibile. Lo scenario post-apocalittico è solido, ma fatica a sorprendere. In sessant’anni abbiamo visto decine di libri, film e serie simili, e oggi la storia appare poco originale. Ci sono pochi sussulti, pochi momenti davvero memorabili. E soprattutto, manca quasi del tutto il sottotesto politico. Dove il fumetto era un grido di allarme e denuncia, qui la metafora si fa opaca, quasi assente. Rimane un messaggio di resistenza collettiva, sì, ma generico, annacquato. Non c’è il peso della storia, non c’è quel senso di urgenza che rendeva L’Eternauta così potente.
Alla fine, ci troviamo davanti a una serie ben confezionata, con buoni attori e una regia solida, ma che rischia di confondersi con tante altre produzioni simili. Una seconda stagione è già stata annunciata, e forse ci sarà spazio per approfondire meglio alcune tematiche solo accennate.
Nel frattempo, se questa serie servirà almeno a spingere qualche spettatore curioso a riscoprire il fumetto originale – recentemente ripubblicato da Panini in una bellissima edizione orizzontale – allora avrà comunque fatto qualcosa di importante.
Serie TV
Adolescence
Jack Thorne, Stephen Graham, Philip Barantini
Mi sono recuperato questa serie prodotta da Netflix, tanto discussa sia per le tematiche che per la messa in scena. Adolescence è una miniserie britannica in quattro episodi che, prendendo spunto dal brutale femminicidio compiuto da un ragazzino di tredici anni, affronta temi come l’adolescenza contemporanea, la mascolinità tossica e, soprattutto, l’incomprensione degli adulti nei confronti dei giovani di oggi.
La storia si apre con l’arresto di Jamie Miller, un ragazzo di 13 anni accusato dell’omicidio di una compagna di scuola, Katie Leonard. L’intera narrazione si sviluppa in tempo reale attraverso quattro episodi – ciascuno girato in un unico piano sequenza – che seguono le fasi successive all’arresto: dall’interrogatorio alla confessione, fino alle conseguenze legali e familiari. La serie non si concentra tanto sul "come" è avvenuto il crimine, quanto sul "perché", esplorando le influenze sociali e psicologiche che hanno portato Jamie a compiere un gesto così estremo.
Adolescence offre un ritratto inquietante e realistico del mondo adolescenziale di oggi, spesso invisibile agli occhi degli adulti. Mostra come i social media e la ricerca ossessiva di approvazione e popolarità possano influenzare negativamente i giovani, contribuendo a fenomeni come il bullismo e l’isolamento. Sotto la superficie di un ragazzino tranquillo, con buoni voti e abitudini apparentemente innocue, emerge come alcune teorie misogine popolari in rete, diffuse nella comunità nota come "manosfera" e nei gruppi Incel - come quella secondo cui l'80% delle donne sceglie solo il 20% degli uomini, possono radicalizzare giovani ragazzi fragili e confusi. Una delle scene più interessanti è quella presente nel secondo episodio, ambientato quasi interamente nel liceo. Mentre l'ispettore, insieme alla sua collega, cerca di interrogare i ragazzi alla ricerca dell'arma del delitto ma soprattuto di un movente, viene avvicinato proprio da suo figlio – che frequenta la stessa scuola e a sua volta subisce bullismo – rivelando che Katie aveva pubblicamente umiliato Jamie su Instagram, definendolo un incel attraverso un codice fatto di emoticon. Questo divario generazionale, l’incapacità degli adulti di comprendere il disagio giovanile, è probabilmente il tema centrale della serie.
Ogni episodio di Adolescence è girato in un unico piano sequenza, senza interruzioni o tagli, una scelta registica audace e complessa che richiede concentrazione millimetrica da parte degli attori e grande abilità tecnica. Mi sono spulciato in rete i vari "making of" per capire se ci sono stati i classici "trucchi di passaggio" ma non li ho trovati. La cinepresa viene passata da un operatore a un altro a mo di staffetta per essere incastrata su un drone, come nel secondo episodio, oppure posizionata davanti alla macchina, come nell'ultimo episodio. quello che ho capito sono stati girati mediamente una decina di volte Questa scelta stilistica è stato uno dei motivi che mi ha accinato a questa serie. Tutto deve essere perfettamente sincronizzato, e il risultato è davvero coinvolgente. Molto bravi anche gli attori, a partire da Owen Cooper, che interpreta Jamie con una naturalezza disarmante, e Stephen Graham, che interpreta il padre, la cui recitazione contribuisce a rendere la narrazione ancora più coinvolgente.
I quattro episodi non sono tutti sullo stesso livello. Il più riuscito, a mio avviso, è il primo, con l’irruzione della polizia in casa Miller alle prime luci dell’alba. Anche il secondo mantiene alta la carica emotiva, culminando in un finale suggestivo con la cover di Fragile di Sting cantata da un coro di ragazzi. Il terzo episodio, centrato sul colloquio tra Jamie e la psicologa, e soprattutto l’ultimo – incentrato sulla famiglia – risultano invece un pò troppo dilatati.
Nel complesso ho trovato l'intera miniserie un'opera coraggiosa che invita a riflettere sui problemi dell'adolescenza nella nostra società.

Black Mirror (stagione 7)
Charlie Brooker
Black Mirror non solo è tornata, ma lo ha fatto nella sua forma migliore.
Dopo la deludente sesta stagione di un paio d’anni fa, la serie creata da Charlie Brooker torna su Netflix con sei nuovi episodi, dalla durata variabile (dai quaranta minuti all'ora e mezza), e soprattutto con un'identità ritrovata. La settima stagione abbandona le derive horror e soprannaturali degli ultimi tempi per riportare al centro la tecnologia, la società e i futuri possibili, sempre più vicini.
Il primo episodio, "Gente comune", è a mio avviso il più riuscito della stagione. La storia segue Amanda e Mike (Rashida Jones e Chris O'Dowd — sì, proprio il Roy di The IT Crowd), una coppia qualunque con il sogno di avere un figlio. Quando Amanda scopre di avere un tumore al cervello, la loro unica speranza è affidarsi a Rivermind, una compagnia in grado di rimuovere la parte malata e sostituirla con una porzione sintetica, la cui memoria è però collegata a un server remoto. L’operazione è gratuita, ma il canone mensile che la coppia è costretta a sottoscrivere si rivelerà invasivo, costoso e totalizzante. È una satira feroce contro la logica degli abbonamenti perpetui e l'illusione della gratuità. Un futuro opprimente, plausibile, angosciante nella sua verità.
"Bête Noire" è più leggero nel tono, ma non meno inquietante. Protagonista è una ricercatrice alimentare che lavora per un'azienda dolciaria e che si ritrova faccia a faccia con una sua ex compagna del liceo, appassionata di tecnologia, vittima di bullismo e oggi esperta di informatica quantistica. Ne nasce un thriller psicologico fatto di vendetta e manipolazione della memoria. È forse l’episodio più "fantascientifico" della stagione e anche uno dei più sorprendenti.
Con "Hotel Reverie", il tono cambia ancora. Una giovane attrice accetta di prendere parte a un remake immersivo di un film romantico anni ’40. La sua coscienza viene trasferita in una simulazione dove interagisce con repliche digitali dei personaggi dell'originale. Episodio elegante, malinconico, ma, a mio avviso, il meno incisivo.
"Plaything" è una piccola perla per gli appassionati di videogiochi. Peter Capaldi interpreta un critico videoludico che riceve una copia di Thronglets, un gioco simulativo con creature digitali in grado di evolversi e comunicare, in pratica un Tamagotchi portato all’estremo. Tra nostalgia anni ’90, acidi lisergici e riflessioni sull’intelligenza artificiale, l’episodio gioca (letteralmente) con l’etica del gioco e la responsabilità del giocatore.
"Eulogy" è l’episodio più emozionante. Paul Giamatti è Philip, un uomo sollecitato da una compagnia tech a contribuire a un memoriale digitale della sua ex compagna. Attraverso una tecnologia capace di rielaborare il lutto con un'intelligenza artificiale empatica, Philip affronta i suoi ricordi e scopre segreti nascosti. È un racconto struggente, dove la tecnologia non è più un mostro da temere, ma uno strumento per capire, per perdonare, per chiudere i conti con il passato.
Chiude la stagione "USS Callister: Into Infinity", primo vero sequel della serie, che riprende i personaggi dell’episodio cult della quarta stagione. L’equipaggio della USS Callister è ora un gruppo di pirati spaziali in fuga, in un universo virtuale che mescola avventura e satira sociale. È l’episodio più spettacolare, anche se meno profondo.
Non c’è più l’effetto sorpresa dei primi anni, ma Black Mirror dimostra di avere ancora molto da dire. Il ritorno all’origine, alla tecnologia come specchio oscuro dell’umanità, è evidente. Ci sono scelte discutibili, certo, e non tutti gli episodi sono allo stesso livello, ma il salto di qualità rispetto alla sesta stagione è notevole.
La serie torna a inquietare, ma con una malinconia nuova, fatta di silenzi, crepe e ferite emotive. Non è solo il futuro a spaventarci, ma le emozioni che abbiamo perso per strada. È meno futuristica, più umana. E proprio in questa fragilità ritrovata — penso a episodi come Eulogy —